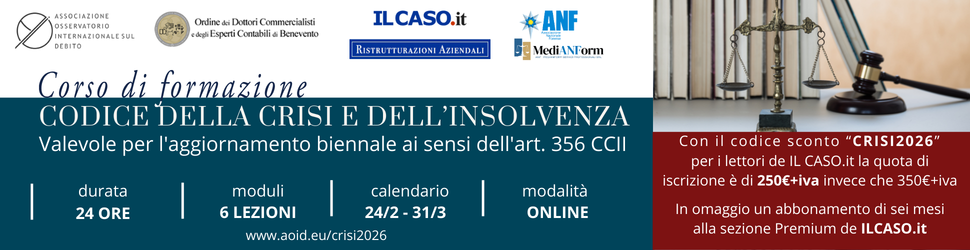ProcCivile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 29/07/2025 Scarica PDF
Appunti in tema di astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ.: onere di allegazione e rinuncia tacita
Biagio Ciliberti, Avvocato in MilanoSommario: 1. Premessa e inquadramento. - 2. Cenni sull’astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ.: in particolare, l’onere di allegazione gravante sul promissario. - 3. La morfologia della rinuncia tacita all’astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ. - 4. Conclusioni.
* * *
Il principio di astrazione processuale di cui all’art. 1988 cod. civ. è stato oggetto di una elaborazione giurisprudenziale complessivamente coerente nei presupposti, ma che dimostra divergenze applicative in relazione ad alcuni specifici profili.
Muovendo dalla pronuncia della Corte d’Appello di Milano n. 1853 del 16 luglio 2020 e dalla conferma resa dalla Corte di Cassazione, il presente contributo intende approfondire un tema poco esplorato (paradossalmente, anche dai commenti disponibili alle medesime pronunce, che si sono concentrati sulla sorte dei c.d. patti matrimoniali), ma di rilevante impatto pratico: se e quando il giudice, valorizzando specifiche condotte processuali del creditore, possa ravvisare una rinuncia tacita al beneficio probatorio previsto dall’art. 1988 cod. civ., con conseguente reviviscenza della disciplina generale in materia di onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ.
A tal fine, si procederà a una sintetica ricostruzione della vicenda processuale oggetto delle pronunce richiamate, cui seguirà un’esposizione dei principi generali in tema di astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ., con particolare attenzione ai profili relativi all’onere di allegazione del rapporto fondamentale e alla possibile rinuncia, anche tacita, al beneficio probatorio.
1. Premessa e inquadramento
Per l’esame che segue, appare preliminarmente opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione della fattispecie concreta oggetto delle pronunce richiamate.
Con atto di citazione, l’attrice ha convenuto l’ex marito dinanzi al Tribunale di Como, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 500.000,00, della quale quest’ultimo si era dichiarato debitore in una scrittura privata - sottoscritta da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio - nel caso di separazione.
Il Tribunale, con sentenza n. 1454 pubblicata in data 18 ottobre 2018, ha rigettato la domanda attorea, adoperandosi, stante l’assenza di una precisa qualificazione giuridica della scrittura azionata, in un’approfondita operazione ermeneutica tesa ad identificare l’astratto tipo contrattuale cui ricondurre il negozio stipulato dai contraenti.
Esaminate tutte le possibili qualificazioni, il giudice di prime cure ha comunque concluso per la nullità della scrittura: (i) se intesa come “sanzione” connessa all’eventuale separazione, poiché integrerebbe un indebito meccanismo dissuasivo e coercitivo della libertà coniugale; (ii) se sussunta nella categoria dei patti matrimoniali, poiché colliderebbe con il principio di indisponibilità dello status di coniuge ai sensi dell’art. 160 cod. civ.; (iii) se qualificata, infine, come promessa di liberalità sottoposta a condizione, poiché contrasterebbe con lo spirito liberale della donazione e, comunque, con l’obbligo di forma solenne ex artt. 782 e 1351 cod. civ.
Inoltre, a giudizio del Tribunale, la scrittura sarebbe stata inefficace anche se intesa quale ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ., posto che il riconoscimento avrebbe avuto ad oggetto una obbligazione nulla e, come tale, priva di effetti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Como, ha interposto appello la parte attrice, censurando l’errata qualificazione della scrittura quale patto matrimoniale. Ad avviso dell’appellante, in realtà, la scrittura sarebbe consistita in un mero riconoscimento di debito, da onorare al verificarsi della condizione sospensiva della separazione: l’atto ricognitivo si sarebbe fondato sulla consapevolezza dell’ex marito di aver ricevuto e di dover ancora ricevere, a titolo di mutuo, ingenti somme di denaro dalla moglie, circostanza documentata da numerosi versamenti bancari prodotti in giudizio.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1853 pubblicata in data 16 luglio 2020, limitando la propria analisi alla prospettazione dell’appellante (i.e., la prospettata ricognizione di debito), ha rigettato l’appello, ritenendo, da un lato, che la condotta processuale tenuta dall’attrice in primo grado dovesse essere considerata quale rinuncia implicita al principio di astrazione di cui all’art. 1988 cod. civ. e, dall’altro lato, che l’attrice-appellante non avesse provato l’esistenza del rapporto fondamentale a sostegno della sua pretesa.
Sul piano probatorio, il giudice del gravame ha osservato che i versamenti e gli accrediti sul conto comune risultavano effettuati dalla moglie in tempi significativamente posteriori alla data in cui era stata redatta la scrittura: poiché la ricognizione di debito, per la sua natura meramente riproduttiva di obbligazioni preesistenti, non avrebbe potuto riguardare un’obbligazione non ancora sorta, la prova del credito è stata giudicata insufficiente.
Inoltre, la Corte d’Appello ha osservato che il convincimento relativo all’esistenza del rapporto fondamentale non avrebbe potuto neppure essere desunto dalla prova della mera consegna di assegni bancari o somme di denaro.
L’appellante, pertanto, ha impugnato la pronuncia della Corte d’Appello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 cod. civ., in quanto il giudice del gravame si sarebbe sottratto al dovere di qualificazione della scrittura privata prodotta, definita “a-tecnicamente” come ricognizione di debito, ma da intendersi quale accordo tra i coniugi per regolare i rapporti matrimoniali successivamente alla separazione e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 160 cod. civ., in punto di ritenuta invalidità dei patti matrimoniali.
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle censure: in particolare, con riferimento al primo motivo, ha osservato che la Corte d’Appello - coerentemente con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per cui l’appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium[1]- aveva correttamente individuato, sulla base delle argomentazioni esposte nel gravame, le parti della decisione impugnata oggetto di censura e vagliato la fondatezza delle doglianze dell’appellante; con riferimento al secondo motivo, invece, ha rilevato la novità della questione sollevata, non essendo stata specificamente contestata in appello la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla nullità o inefficacia dell’accordo inter partes.
Nessuna statuizione, dunque, è stata resa dalla Corte di legittimità in ordine alla validità del c.d. patto matrimoniale, tema frequentemente dibattuto in dottrina e meritevole di tutt’altro tipo di studio e riflessione.
Restano oscure, quantomeno a chi scrive, le motivazioni per cui il provvedimento della Corte di Cassazione è stato così massimato: “È nullo il patto con il quale due coniugi, per il caso della futura separazione, convengono che l’uno versi all’altro una somma di denaro: se [qualificabile] come patto matrimoniale, è nullo per illiceità della causa; se considerato come un preliminare di donazione sospensivamente condizionato all’evento della separazione dei coniugi, è nullo per violazione del divieto di promettere una donazione”.
2. Cenni sull’astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ.: in particolare, l’onere di allegazione gravante sul promissario.
Com’è noto, in materia di responsabilità contrattuale, secondo il celebre insegnamento della pronuncia n. 13533 del 30 novembre 2001 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il creditore “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Come parimenti noto, l’art. 1988 cod. civ., in deroga all’ordinario regime dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ., attribuisce al destinatario di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito il beneficio di non dover provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza è presunta sino a prova contraria.
La norma codicistica, invero, contempla due distinti istituti, ossia la promessa di un soggetto di adempiere una prestazione in relazione ad un rapporto obbligatorio e la ricognizione di un debito esistente, dettando una disciplina comune.
Si tratta, rispettivamente, di una dichiarazione di volontà e di una dichiarazione “ricognitiva” di scienza[2], entrambe aventi ad oggetto l’asseverazione di diritti o rapporti giuridici, con incidenza esclusivamente processuale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza, difatti, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non costituiscono autonoma fonte di obbligazioni: esse realizzano un’astrazione meramente processuale della causa debendi, che determina una relevatio ab onere probandi in favore del destinatario della dichiarazione, il quale è in tal modo dispensato dall’onere di provare l’esistenza di un preesistente rapporto fondamentale[3], della cui esistenza o validità non può comunque prescindersi sotto il profilo sostanziale[4].
Il rapporto fondamentale, per effetto della promessa, si presume iuris tantum esistente, valido ed efficace, salva la possibilità per il dichiarante di provare l’inesistenza, l’invalidità e l’estinzione di tale rapporto[5].
Secondo l’impostazione tradizionale, tuttavia, l’onere probatorio posto a carico del dichiarante differisce a seconda del fatto che la promessa o ricognizione sia titolata, ove faccia riferimento alla ragione dell’obbligazione o al fatto storico da cui essa è scaturita, o “pura” (o astratta), ove non contenga alcuna indicazione in merito al rapporto fondamentale: nel primo caso, la prova liberatoria è più agevole, essendo richiesta al dichiarante la dimostrazione che tale rapporto sia inesistente o venuto meno[6]; nel secondo caso, invece, a rigore, il dichiarante dovrebbe dimostrare che non sussista in assoluto alcuna ragione per cui egli possa avere un debito nei confronti del promissario[7].
Nell’ipotesi di dichiarazione-ricognizione non titolata (o “pura”), pertanto, sembrerebbe configurarsi per il dichiarante una vera e propria probatio diabolica e le possibilità di successo, di fatto, sarebbero relegate al positivo esperimento del giuramento decisorio.
La giurisprudenza, tuttavia, ha aderito ad un’impostazione che attenua rispetto all’impostazione tradizionale l’onere probatorio gravante sull’autore della promessa o della ricognizione.
Così, secondo l’opinione consolidata, nelle ipotesi in cui il creditore - nonostante la dichiarazione “a-titolata” - abbia dedotto in giudizio la causa debendi, il dichiarante può limitarsi a fornire la prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto del presunto creditore, con specifico riferimento al rapporto dedotto in giudizio (non dissimilmente dall’ipotesi della promessa-ricognizione titolata).
Non unanimemente ammessa, invece, è la possibilità per l’attore di limitarsi a produrre la dichiarazione “pura”, omettendo qualsivoglia allegazione del rapporto a fondamento del proprio credito.
Secondo un primo orientamento, più favorevole per il debitore, l’azione proposta ex art. 1988 cod. civ. rimarrebbe in ogni caso sempre un’azione causale, anche laddove fondata su una promessa di pagamento o ricognizione di debito non titolata: per tale motivo, sarebbe assolutamente necessario e indefettibile che la parte che se ne voglia avvalere indichi espressamente, nella domanda di pagamento, quale sia il rapporto causale sottostante[8].
Secondo un diverso orientamento, invece, al creditore sarebbe riconosciuta la facoltà di tacere in ordine al rapporto fondamentale: in tal caso, graverebbe sul dichiarante l’onere di indicare il rapporto fondamentale alla stregua del quale era stata rilasciata la dichiarazione e provarne il fatto modificativo, impeditivo o estintivo; spetterà eventualmente, poi, al creditore l’allegazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito. A sostegno di tale conclusione, infatti, si è osservato che l’astrazione processuale di cui all’art. 1988 cod. civ. “non può intendersi nel senso che al debitore compete l’impossibile prova dell’assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore a quella di cui abbia dimostrato l’insussistenza”[9]: la mancata indicazione tempestiva (ossia, nel primo atto successivo) da parte del creditore - che graverebbe sul creditore, a fortiori, a fronte della contestazione del dichiarante-debitore dell’esistenza di qualsivoglia rapporto - non potrebbe comunque che condurre al rigetto della sua pretesa.
I due orientamenti, sostanzialmente, differiscono in ordine al momento in cui sorge l’onere di allegazione del rapporto fondamentale a carico del creditore: sin dal momento della proposizione della domanda, per il primo orientamento, solo a fronte della contestazione della controparte, per l’orientamento opposto.
Non risulta, a quanto consta, una compiuta presa di posizione della giurisprudenza di legittimità: le pronunce di merito si sono alternativamente riferite, per un verso, all’arresto n. 8891 del 14 aprile 2010, nel quale la Corte di legittimità ha desunto dalla considerazione per cui l’astrazione di cui all’art. 1988 cod. civ. riveste esclusivamente carattere processuale, la conseguenza che “il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo”[10] o, per altro verso, alla pronuncia del 7 settembre 2016, n. 17713, che, incidentalmente, ha osservato che l’indicazione del rapporto fondamentale possa essere fatta “dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata)”[11].
3. La morfologia della rinuncia tacita all’astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ.
Con riferimento, invece, alla possibilità per il destinatario della promessa o della dichiarazione ricognitiva di rinunciare all’astrazione processuale di cui all’art. 1988 cod. civ., la giurisprudenza mostra un orientamento pressoché uniforme.
Ciò è vero, anzitutto, con riferimento alla rinuncia espressa, stante la derogabilità delle norme dettate in materia di onere probatorio (nei limiti di cui all’art. 2698 cod. civ.) e, dunque, di ripristinare convenzionalmente la distribuzione dell’onus probandi di cui all’art. 2697 cod. civ.
Analoga convergenza si registra anche con riferimento all’ammissibilità della rinuncia tacita o per facta concludentia all’astrazione processuale, al netto delle divergenze in merito alle concrete circostanze che ne consentano l’affermazione.
La questione, dunque, riguarda appunto la configurazione concreta della condotta assunta dal creditore che consenta di affermare o meno che vi sia stata una rinuncia tacita ai benefici di cui all’art. 1988 cod. civ.
Sul punto, occorre innanzitutto osservare che, secondo l’orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, “la mera indicazione del rapporto fondamentale da parte del promissario non importa rinuncia al vantaggio della dispensa dell’onere della prova”[12] (enfasi aggiunta).
Maggiori divergenze emergono, invece, in ordine alla qualificazione della condotta del promissario che tenti o si offra di provare l’esistenza del rapporto fondamentale.
In linea di principio, in realtà, la giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel ritenere che, ai fini della configurabilità della rinuncia implicita all’astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ., è necessario che la parte non onerata manifesti in modo inequivoco di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dalla regola sulla distribuzione dell’onere probatorio, mostrando di voler “subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta”[13].
Sul piano concreto, tuttavia, si registra una diversa configurazione della nozione di “inequivoca manifestazione della volontà abdicativa”[14].
Per un primo orientamento, meno rigoroso per il promissario, la stessa non sarebbe ravvisabile neppure nei casi in cui il promissario tenti o offra di provare il rapporto fondamentale[15]: in tale prospettiva, non sarebbe neppure sufficiente “che la parte sollevata dall’onere di provare il rapporto fondamentale ne offra egualmente la prova”[16].
Del pari, a fortiori, si è esclusa la ravvisabilità della rinuncia implicita nei casi in cui il promissario, subordinatamente al mancato accoglimento della domanda principale fondata sulla promessa, abbia offerto di provare il rapporto ad essa sottostante[17].
Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale deve intendersi rinunciata quando il promissario, nell’azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante, chiedendo di provarlo di propria iniziativa[18]: in tale prospettiva, sarebbe qualificabile come rinuncia implicita al vantaggio probatorio l’istanza istruttoria elevata dal promissario avente la finalità di provare l’esistenza del rapporto fondamentale[19].
Anche i fautori dell’orientamento da ultimo riportato, in ogni caso, escludono che la volontà abdicativa possa essere ravvisata nei casi in cui il promissario si sia limitato a formulare una richiesta istruttoria avente ad oggetto l’esistenza del rapporto fondamentale al solo fine di “reagire” alle eccezioni del promittente: cfr., ad es., Cass. 22 agosto 2018, n. 20899, secondo cui “[n]on può, invece, ravvisarsi quella implicita rinuncia nella condotta del creditore che chieda di provare il rapporto sottostante in via di eccezione e non in via d'azione, per reagire alle eccezioni del convenuto promittente”[20].
La dottrina è apparsa sostanzialmente contraria alla configurabilità della rinuncia implicita al ricorrere del solo tentativo o della sola offerta del litigante non onerato di provare in giudizio l’esistenza del rapporto fondamentale.
Così, ad esempio, si è richiamato il principio dell’acquisizione processuale, per cui, com’è noto, le risultanze istruttorie, a prescindere dalla parte ad iniziativa della quale sono state assunte, concorrono tutte indistintamente a formare il convincimento del giudice[21]: ciò, tuttavia, non consentirebbe di desumere il venir meno dell’inversione probatoria prevista in favore del promissario, posto che l’offerta di prova consisterebbe in un atto di esercizio del diritto alla prova[22], che mostrerebbe di perseguire proprio il fine di ottenere un pronunciamento a sé favorevole e al quale, pertanto, non potrebbero ricollegarsi effetti sfavorevoli.
Inoltre, si è osservato che, ritenendo ammissibile la rinuncia tacita, si finirebbe per liceizzare atteggiamenti passivi della parte del giudizio, controproducenti in termini di giusto processo[23]: al contrario, la condotta del promissario dovrebbe essere riconosciuta come forma di collaborazione processuale ed espressione di esercizio del diritto alla prova.
4. Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare opportuno individuare alcune coordinate sistematiche utili ad orientare l’interprete nel delicato bilanciamento tra l’onere di allegazione del rapporto fondamentale e la rinuncia tacita al beneficio probatorio di cui all’art. 1988 cod. civ.
Con riferimento al primo aspetto, deve innanzitutto osservarsi che appare preferibile la tesi che onera la parte attrice - anche nei casi in cui sia stata destinataria di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito “pure” - di un onere di allegazione del rapporto fondamentale, in quanto più rispettosa del principio di chiarezza e completezza degli atti processuali e maggiormente coerente con la natura comunque causale dell’azione. Ammettere che il promissario-creditore possa calibrare ex post le proprie allegazioni sulla base delle difese avversarie, inoltre, significherebbe sovvertire la logica del processo, snaturandone l’impianto ordinario e compromettendo la parità tra le parti.
D’altro canto, l’onere di allegazione, seppur strettamente connesso all’onere probatorio, non si identifica con esso: come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 15895 del 13 giugno 2019, in materia di prescrizione nel rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, “pur nella loro indiscutibile connessione, l'onere di allegazione è concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo. Non è ozioso, infatti, rilevare che l'aver assolto all'onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice”.
A parere di chi scrive, poi, anche per motivi di ordine sistematico, non vi sarebbero ragioni per discostarsi dalle già solide coordinate elaborate con riferimento ad un altro elemento della responsabilità contrattuale, anch’esso oggetto di una presunzione iuris tantum, ossia l’inadempimento, in relazione al quale non si dubita che l’attore debba quantomeno “allegare (senza onere di provarlo) che adempimento non vi è stato”[24].
È evidente, peraltro, che la configurazione di un onere di allegazione in capo al creditore-promissario con riferimento al rapporto fondamentale sottostante rende superflua ogni distinzione, a livello probatorio, tra promessa di pagamento titolata e non titolata, la quale d’altronde non trova rispondenza nella lettera dell’art. 1988 cod. civ.
Con riferimento, invece, alla rinuncia implicita all’astrazione processuale, la giurisprudenza richiede al creditore che produca in giudizio la promessa di pagamento o la ricognizione di debito di mantenere una posizione processuale “passiva”, spesso ravvisata - come si è visto - nella condotta di colui che non aveva “dedotto né chiesto di provare il rapporto sottostante l’emissione del titolo” [25].
Un siffatto modo di argomentare, tuttavia, potrebbe porsi in contraddizione con l’orientamento giurisprudenziale che configura a carico del creditore l’onere di allegazione del rapporto fondamentale (di cui si è dato atto supra): in ogni caso, non sono reperibili pronunce che abbiano desunto la rinuncia implicita ai benefici dell’art. 1988 cod. civ. dalla sola allegazione del rapporto fondamentale, che appare, dunque, alla luce della giurisprudenza esaminata nel presente contributo, senza dubbio la strategia processuale più avveduta.
A voler coordinare i due orientamenti richiamati, dovrebbe ritenersi che - per scongiurare il rischio che il suo comportamento possa essere inteso quale rinuncia tacita all’inversione dell’onere probatorio ex art. 1988 cod. civ. - l’attore dovrebbe limitarsi ad un chirurgico adempimento all’onere di allegazione, evitando di fornire evidenze a sostegno dell’esistenza del rapporto fondamentale o, comunque, avendo cura di precisare che le stesse non debbano essere intese quale rinuncia al beneficio probatorio.
In definitiva, può osservarsi che la eventuale sussistenza della “inequivoca manifestazione di volontà abdicativa” debba essere necessariamente valutata con riferimento alla consapevolezza della parte non onerata di accollarsi volontariamente l’onere probatorio altrui e l’eventuale rischio di insuccesso: così, se le ipotesi in cui il promissario “reagisca” alle allegazioni avversarie non possono determinare il ripristino dell’ordinario regime probatorio (come, del resto, riconosce graniticamente la giurisprudenza), il tentativo ab initio del promissario di dimostrare il rapporto fondamentale non può essere valutato aprioristicamente, ma necessita di un’indagine compiuta delle allegazioni e del complessivo assetto delle difese, onde accertare che l’assunzione di quell’onere derivi da una scelta processuale consapevole e non si traduca in un ingiustificato pregiudizio a carico dell’attore.
[1] Cfr., sul punto, la richiamata Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199.
[2] Così, C.A. Graziani, Le promesse unilaterali, in Tratt. Rescigno, Torino, 1984, 668.
[3] O, per utilizzare l’espressione delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, della “fonte negoziale del suo diritto”.
[4] Per l’autorevole affermazione del principio, si v. Cass. 15 maggio 2023, n. 13215, ove si legge: “[l]a ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 c.c. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito”. Tra le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, si v. Cass., ord. 28 agosto 2024, n. 23285; Cass. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682; Cass., ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26334; Cass. 15 maggio 2009, n. 11332. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma 5 giugno 2025, n. 3540; Trib. Pisa 22 maggio 2025, n. 523; Trib. Bologna 3 ottobre 2024, n. 2577; Trib. Foggia 19 febbraio 2024, n. 500; App. Bari 23 marzo 2022, n. 489; App. Napoli 7 febbraio 2020, n. 563.
[5] Cfr., sul punto, Cass. 16 settembre 2013, n. 21098; Cass. 29 settembre 2011, n. 19929.
[6] Cfr., di recente, Cass. 15 maggio 2018, n. 11766. Ovviamente, come ricordato di recente da Cass. 15 maggio 2023, n. 13215, nel caso di promessa titolata, non è sufficiente che il debitore “alleghi e dimostri che altro rapporto fondamentale è stato estinto, dovendo viceversa provare l'identità tra tale rapporto e quello presunto per effetto della ricognizione di debito, non bastando una mera compatibilità astratta tra i due titoli”. Conformi: Cass. 15 maggio 2018, n. 11766; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4019.
[7] Ad es., P. Schlesinger - A. Trimarchi, Manuale di diritto privato, XXIV ed., Giuffré, p. 844.
[8] Nella giurisprudenza di merito, cfr. App. Catania 3 maggio 2025, n. 626; Trib. Torino 31 marzo 2025, n. 1594; Trib. Treviso 13 febbraio 2018, n. 311.
[9] Così Cass. 17 settembre 2016, n. 17713; Cass. 14 aprile 2010, n. 8891 e, più risalenti, Cass. 29 gennaio 1991, n. 885 e Cass. 28 febbraio 1987, n. 2159. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Bari 15 gennaio 2025, n. 97; Trib. Firenze 19 dicembre 2024, n. 4081; Trib. Pisa 24 ottobre 2023, n. 1314; App. Bologna 20 febbraio 2023, n. 3807. Cfr. anche Cass. 10 marzo 2006, n. 5245, per cui il principio è in linea con quello, consolidato, in ordine alla imputazione del pagamento di cui all’art. 1193 cod. civ. ed alla distribuzione del relativo onere della prova, secondo il quale “nel caso in cui il debitore convenuto eccepisca il pagamento del debito ed il creditore opponga che tale pagamento debba imputarsi a diverso debito, il secondo ha l’onere di provare l’esistenza dell’altro credito che afferma essere stato adempiuto” (cfr., ex multis, Cass. 12 febbraio 2000, n. 1571, nonché Cass. 18 dicembre 1999, n. 14282). In merito alla legittimità della condotta processuale del creditore che agisca in giudizio senza dedurre la causa petendi, possibile riscontrare una giurisprudenza, in apparenza, minoritaria, per cui “[l]’azione proposta ex art. 1988 c.c. pur determinando un’astrazione processuale in termini probatori rimane pur sempre un’azione causale, anche laddove fondata su una promessa di pagamento cd. pura o non titolata, per cui è assolutamente necessario e indefettibile che la parte che se ne avvalga indichi espressamente, nella sua domanda di pagamento, quale sia il rapporto causale azionato, a fronte della contestazione del promittente della sussistenza di qualsivoglia rapporto”.
[10] Cfr., Cass. 14 aprile 2010, n. 8891, per cui “[i]l carattere processuale e non già sostanziale dell'astrazione insita nella promessa di pagamento pura comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall'onere di provarlo”, richiamata anche da Cass. 27 febbraio 2023, n. 5827.
[11] Ex plurimis, la già menzionata Trib. Pisa 24 ottobre 2023, per cui il promittente, “a fronte del silenzio - legittimo - [del promissario] circa la causa debendi, ha attribuito alla dichiarazione ricognitiva una funzione di garanzia rispetto al coevo patto tra cedente e cessionario dell’azienda” (enfasi aggiunta).
[12] App. Roma 5 giugno 2025, n. 3540, che richiama Cass. 14 aprile 2010, n. 8891. Conformi: Cass. 11 giugno 2010, n. 14066; Cass. 19 maggio 2006, n. 11775.
[13] Cass. 14 giugno 2022, n. 19164; Cass. 9 giugno 2016, n. 11790; Cass. 11 giugno 2010, n. 14066.
[14] I termini del dibattito sono compiutamente ricostruiti da Cass. 27 febbraio 2023, n. 5827, nonché da Cass. 23 giugno 2016, n. 13039.
[15] Per l’autorevole affermazione del principio, cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19406; Cass. 11 giugno 2010, n. 14066; Cass. 7 luglio 2005, n. 14306. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Padova 15 gennaio 2015, n. 137.
[16] Cfr. Cass. 10 agosto 2017, n. 19994 e la giurisprudenza ivi richiamata, Cass. 23 giugno 2016, n. 13039; Cass. 9 giugno 2016, n. 11790, nonché Cass. 11 giugno 2010, n. 14066.
[17] Cfr. Cass. 27 febbraio 2023, n. 5827, per cui deve escludersi che la richiesta di provare il rapporto fondamentale con successiva ammissione e assunzione della prova rientri nel novero delle situazioni suscettibili di determinare rinuncia implicita al beneficio dell’inversione dell’onere della prova. Cfr. anche Cass. 19 maggio 2006, n. 11775; Cass. 18 luglio 1997, n. 6642.
[18] La prima affermazione del principio richiamato risale a Cass. 11 luglio 1985, n. 4121. Cfr., più di recente, Cass. 15 luglio 2024, n. 19406; Cass. 21 settembre 2022, n. 27611; Cass. 30 maggio 2019, n. 14773. Cfr. anche Cass. 31 marzo 2010, n. 7787, in un giudizio in cui, tuttavia, come osservato anche da Cass. 22 agosto 2018, n. 20899, il principio per cui la richiesta di prova del rapporto sottostante vale come implicita rinuncia all’astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ. è stato invocato non dal debitore che intendeva sottrarsi al pagamento, ma dallo stesso creditore, al fine di vedersi ammettere le prove da lui richieste. Peraltro, giova osservare, è quantomeno dubbio che la nozione di “inequivoca manifestazione della volontà abdicativa” possa assumere una diversa configurazione a seconda del fatto che sia invocata dal debitore o dal creditore.
[19] A tale ipotesi è stata assimilata quella in cui, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore promittente, l’offerta di prova venga dal creditore promissario: cfr., Cass. 30 maggio 2019, n. 14773.
[20] È ricorrente in giurisprudenza l’affermazione del seguente principio: “la rinuncia al vantaggio della dispensa dall’onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall’effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell’azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo “sua sponte” di provarlo”, richiamato, ad es., da Cass. 15 luglio 2024, n. 19406; Cass. 15 maggio 2023, n. 13215; Cass. 21 settembre 2022, n. 27611; Cass. 14 giugno 2022, n. 19146; Cass. 30 maggio 2019, n. 14773. Nella giurisprudenza di merito, cfr., ad es. Trib. Catania 3 maggio 2025, n. 626, App. Bari 23 settembre 2022, n. 1592, Trib. Vicenza 15 aprile 2021, n. 789.
[21] Taruffo, voce Onere della prova, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, 1996, 75.
[22] Patti, Sub art. 2698 c.c. Delle prove. Art. 2697-2739, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2015, p. 290.
[23] E. Betti, Su di una pretesa inversione dell’onere della prova per fatto concludente, in Giur. it., 1950, I, pp. 262 ss.
[24] Cfr. nuovamente, Cass., Sez. Un., 30 novembre 2001, n. 13533.
[25] Cfr., sul punto, Cass. 15 luglio 2024, n. 19406.
Scarica Articolo PDF