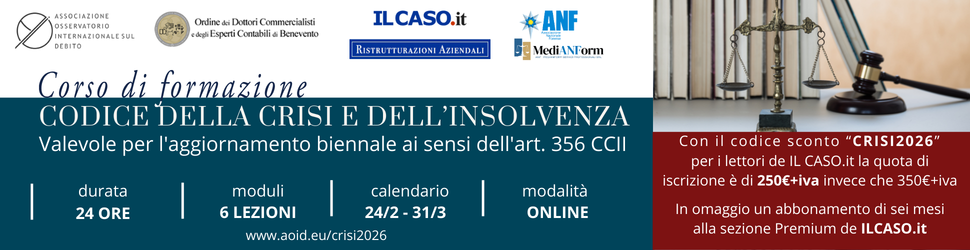Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/07/2025 Scarica PDF
Liquidazione del danno da deportazione e analogia con l’ingiusta detenzione: verso un parametro di giustizia piena. (Nota a Tribunale di Genova, 23 aprile 2025)
Cristina Florean, Avvocato in VeronaSommario: 1. Premessa; 2. Legittimazione passiva e ruolo del MEF; 3. L’imprescrittibilità dei diritti risarcitori; 4. L’onere della prova; 5. I criteri risarcitori: analogia con l’ingiusta detenzione e panorama nazionale; 6. Conclusioni: Oltre l’indennizzo. L’analogia con l’ingiusta detenzione come strumento per il pieno risarcimento del danno da deportazione
1. Premessa
La sentenza del Tribunale di Genova (Giudice Dott. Pasquale Grasso) del 23 aprile 2025 rappresenta un tassello rilevante nel mosaico delle decisioni civili che affrontano la questione della responsabilità risarcitoria per i crimini commessi dalle forze armate tedesche contro cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale, in particolare nei confronti degli Internati Militari Italiani (IMI).
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale concerne il ricorso proposto dal figlio di un militare italiano, il quale, il 21 settembre 1943, mentre era imbarcato su una nave militare italiana ormeggiata alla Spezia, fu catturato dalle truppe tedesche, deportato in Germania – inizialmente presso il campo di concentramento di Mosburg (Stalag VII) e successivamente nel campo di lavoro Mallak, Comando 3615 – e ridotto in condizioni di schiavitù e di lavoro coatto fino alla liberazione avvenuta il 1° maggio 1945.
La pronuncia si distingue non solo per la solidità dell’argomentazione giuridica, ma anche per il contributo sostanziale che offre alla definizione di un criterio oggettivo ed equo nella liquidazione del danno non patrimoniale, rafforzando una tendenza ormai maggioritaria a favore dell’analogia con l’indennizzo da ingiusta detenzione.
2. Legittimazione passiva e ruolo del MEF
Uno dei profili giuridicamente più rilevanti affrontati dal Tribunale di Genova riguarda la corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato nell’azione risarcitoria proposta iure hereditatis dal figlio di un Internato Militare Italiano, deportato nei campi di lavoro forzato tedeschi.
A fronte della chiamata in giudizio della Repubblica Federale di Germania — rimasta contumace — e dello Stato italiano, si è costituito in giudizio unicamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Secondo quanto eccepito dal MEF, l’art. 43 del D.L. n. 36/2022, istitutivo del Fondo per il ristoro dei danni derivanti da crimini di guerra commessi dalle forze armate del Terzo Reich, avrebbe natura attuativa dell’Accordo italo-tedesco del 1961, reso esecutivo con d.P.R. n. 1263/1962.
Sulla base di tale impostazione, lo Stato italiano sarebbe subentrato nelle obbligazioni risarcitorie della Repubblica Federale di Germania, rendendo superflua la sua vocatio in ius.
Il Tribunale ha rigettato in modo netto questa ricostruzione, chiarendo che il complesso normativo contenuto nell’art. 43 del D.L. 36/2022 si limita a regolare le condizioni di accesso al Fondo istituito presso il MEF, operando esclusivamente nella fase esecutiva.
In particolare, secondo il Tribunale di Genova, in nessun passaggio, né sotto il profilo letterale né sotto quello teleologico, è rinvenibile l’intenzione del legislatore di determinare un fenomeno successorio in senso tecnico-giuridico, ossia un subentro dello Stato italiano quale nuovo soggetto passivo delle pretese risarcitorie originariamente gravanti sulla Germania.
La funzione attribuita allo Stato italiano è dunque limitata alla gestione della fase successiva all’accertamento giudiziale del diritto al risarcimento, che rimane invece fondato su un rapporto obbligatorio sorto tra la vittima del crimine (o i suoi eredi) e il responsabile storico, ovvero la Repubblica Federale di Germania, in quanto successore giuridico del Terzo Reich.
In coerenza con tale impostazione, il giudice ha
ribadito che ilpresupposto per l’accesso al Fondo è costituito
esclusivamente da una sentenza passata in giudicato emessa nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, ovvero il danneggiante che deve essere
necessariamente convenuto in giudizio. La partecipazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, quale destinatario della notifica ai sensi del
comma 6 dell’art. 43 del D.L. n. 36/2022, non incide sull’identità del soggetto
obbligato, né comporta un effetto di successione dal lato passivo del titolo
controverso in capo allo Stato italiano rispetto alla Repubblica Federale di
Germania.
La notifica al MEF assolve, infatti, alla sola funzione di denuntiatio litis,
funzionale all’eventuale accesso al Fondo istituito dallo stesso art. 43, senza
che ciò comporti una modifica della titolarità passiva del rapporto
obbligatorio.
Il Tribunale esclude pertanto che il Ministero — o qualsiasi altro organo dello Stato italiano — possa sollevare eccezioni nel merito dell’azione, riservate invece al soggetto passivamente legittimato, e in particolare nega che il MEF possa eccepire la prescrizione del diritto azionato, trattandosi di eccezione personale riferibile solo al debitore sostanziale.
Questa ricostruzione si colloca in perfetta coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 159/2023, che ha ribadito come titolo per l’accesso al fondo sia una sentenza di condanna passata in giudicato della Repubblica federale di Germania.
Il pagamento delle somme risarcitorie è garantito dallo Stato italiano per ragioni di cooperazione internazionale, senza che ciò incida sulla titolarità del rapporto giuridico sottostante.
La decisione del Tribunale di Genova si allinea così alle più recenti pronunce di merito che hanno riaffermato la necessità di mantenere ferma la legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, valorizzando la centralità del giudizio di accertamento come strumento irrinunciabile per il riconoscimento e la piena tutela dei diritti delle vittime dei crimini nazisti.
3. L’imprescrittibilità dei diritti risarcitori
Il Tribunale di Genova affronta con rigore il tema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da crimini di guerra e contro l’umanità, ponendo particolare attenzione al recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3642 del 2024.
Secondo il Tribunale di Genova, la questione della prescrizione deve essere affrontata alla luce dell’esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario — ormai da tempo consolidata — che sancisce l’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità.
Tale principio ha trovato espressione testuale nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità, nonché nella Convenzione europea adottata nel 1974.
Esso si configura oggi come norma internazionale generalmente riconosciuta e, in quanto tale, trova ingresso automatico nell’ordinamento giuridico interno ai sensi dell’art. 10 della Costituzione.
La conformazione automatica dell’ordinamento italiano al diritto internazionale consuetudinario è stata ribadita in modo autorevole dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 349/2007, nonché dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella decisione n. 5044/2004.
Un punto essenziale evidenziato dal Tribunale riguarda la distinzione – tutt’altro che formale – tra ambito penale e ambito civile.
Il nodo focale della questione è, infatti, stabilire se le norme di diritto consuetudinario internazionale che stabiliscono l’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità possano avere o meno portata retroattiva.
Mentre in sede penale il principio di irretroattività delle leggi sfavorevoli sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. rappresenta un limite invalicabile, tale principio non trova applicazione in ambito civile, dove non esiste l’esigenza di tutela del reo (favor rei).
In altri termini, il principio di imprescrittibilità previsto dalle norme internazionali consuetudinarie può trovare applicazione retroattiva in sede civile, anche con riferimento a fatti anteriori alla sua emersione formale.
È proprio questa la posizione confermata, sia pure in forma incidentale, dalla Cassazione nella citata sentenza n. 3642/2024, la quale ha ritenuto erronea la decisione di merito che escludeva l’imprescrittibilità sulla base dell’art. 25 Cost., dimenticando che tale norma si riferisce unicamente al diritto penale[1].
La Suprema Corte ha quindi riconosciuto la fondatezza della censura sollevata dai ricorrenti, affermando che la norma internazionale sull’imprescrittibilità è nata proprio per regolare anche i fatti pregressi e che la sua efficacia retroattiva in sede civile è coerente con i principi dell’ordinamento.
Infine, il Tribunale osserva che l’art. 43, comma 6, del d.l. n. 36/2022, nella parte in cui richiama gli “ordinari termini di prescrizione”, non incide sulla qualificazione sostanziale del diritto al risarcimento, che resta imprescrittibile per effetto delle norme internazionali recepite ex art. 10 Cost. Lo stesso art. 43, infatti, disciplina esclusivamente i termini decadenziali per l’accesso al Fondo – originariamente fissati in 180 giorni e poi prorogati sino al 31 dicembre 2023 – ma non può essere interpretato come disposizione derogatoria alla regola generale dell’imprescrittibilità delle pretese risarcitorie relative a crimini internazionali.
4. L’onere della prova
Ulteriore profilo particolarmente rilevante affrontato dal Tribunale di Genova riguarda l’onere della prova, tema spesso dirimente nei giudizi risarcitori in materia di deportazioni e crimini di guerra.
Sul punto, il giudice adotta un approccio equilibrato, che valorizza tanto il materiale documentale prodotto dalla parte attrice quanto il contesto storico ampiamente consolidato nella memoria collettiva e nella storiografia ufficiale.
In particolare, il Tribunale afferma che la documentazione versata in atti – specificamente i documenti allegati in sede di instaurazione del procedimento originario – fornisce una prova piena e congrua della deportazione subita dal congiunto dell’attrice, nonché delle condizioni di prigionia e della sottoposizione a lavoro coatto in assenza delle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra.
Le condizioni accertate – che comprendono lavori usuranti, denutrizione, assenza di garanzie minime e igiene – vengono riconosciute come rientranti a pieno titolo nel novero dei crimini di guerra, in quanto lesive dei diritti inviolabili della persona.
Non meno rilevante è l’affermazione secondo cui tali condizioni, praticate sistematicamente dalle forze armate tedesche nei confronti dei prigionieri devono ritenersi fatto notorio[2], e dunque sottratto al rigido meccanismo probatorio previsto dall’art. 2697 c.c.
In assenza di elementi idonei a contrastare tale dato[3] – e nel caso di specie non risultano allegazioni o produzioni difensive in tal senso – il Tribunale richiama il principio giurisprudenziale secondo cui il fatto notorio può essere legittimamente assunto a fondamento della decisione, integrando una forma di conoscenza diretta del giudice che trova riscontro nella realtà sociale e storica condivisa.
Questa impostazione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – condiviso anche da diversi Tribunali italiani (tra cui Milano, Brescia, Firenze, Palermo, Venezia, Ancona, Lecco, Treviso, Ferrara, Pordenone, Ascoli-Piceno, Fermo) – secondo cui non può richiedersi alla parte attrice una prova atomistica e analitica di ciascun elemento del trattamento detentivo e lavorativo[4], quando si tratta di prassi sistemiche ampiamente documentate e riconosciute dalla comunità storiche e dagli organi istituzionali.
In tal senso, si può parlare di una “presunzione storica qualificata”, fondata su fonti coeve, ricerche storiografiche e documentazione ufficiale (inclusi i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’“armadio della vergogna” e l’istituzione al 20 settembre di ogni anno della giornata degli IMI con la L. n. 6/2025), che il giudice può assumere come elemento probatorio in mancanza di smentita specifica.
La sentenza in commento, dunque, fornisce un ulteriore contributo alla definizione del corretto perimetro dell’onere probatorio nei giudizi per danni da deportazione e lavoro coatto, riaffermando che non è richiesto alla vittima o ai suoi eredi un onere probatorio impossibile o eccessivamente gravoso, ma solo la dimostrazione di elementi essenziali, che – nel contesto dato – possono ritenersi provati anche in via presuntiva o notoria.
5. I criteri risarcitori: analogia con l’ingiusta detenzione e panorama nazionale
La quantificazione del danno da deportazione e prigionia, nel caso deciso dal Tribunale di Genova, avviene in applicazione di un criterio equitativo, ispirato alla disciplina prevista per l’indennizzo da ingiusta detenzione.
Tale orientamento, sempre più consolidato a livello nazionale, prende come parametro di riferimento l’importo giornaliero previsto ex artt. 314 – 315 c.p.p. (pari a euro 235,82), poi aumentato in ragione della particolare gravità del trattamento subito.
Il Tribunale, in questo caso, incrementa equitativamente la soglia a euro 300,00 per ogni giorno di prigionia, valorizzando la durata della detenzione, le condizioni disumane patite, la violazione delle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra, nonché lo sfruttamento lavorativo senza alcuna garanzia o retribuzione.
La somma così ottenuta – pari a euro 175.500,00 per 585 giorni di detenzione – è ritenuta comprensiva sia del danno morale sia del danno patrimoniale, e su di essa decorrono gli interessi legali dalla decisione fino al pagamento.
Questa impostazione si inserisce in una più ampia linea giurisprudenziale che riconosce l’applicabilità del criterio dell’ingiusta detenzione quale parametro di liquidazione del danno da deportazione e lavoro coatto nei confronti degli IMI (Internati Militari Italiani). Lo stesso approccio è stato seguito, tra le altre, dalle seguenti decisioni:
· Tribunale di Treviso, 08/11/2018, che per primo adotta il parametro dell’ingiusta detenzione;
· Tribunale di Pordenone, sentenze del 12/09/2023 e del 03/06/2024;
· Tribunale di Lecco, 09/09/2024;
· Tribunale di Milano, 26/02/2025;
· Tribunale di Genova, sentenze del 04/02/2025 e del 23/04/2025 (la presente);
· Tribunale di Ragusa, 04/02/2025;
· Tribunale di Ferrara, 08/04/2024;
· Tribunale di Venezia, 29/04/2025;
· Tribunale di Torino, sentenze dell’08/07/2025 e del 07/07/2025.
In particolare, il Tribunale di Firenze, con sentenza del 21/05/2025, ha ulteriormente affinato il parametro, affermando che:
“Si stima equo un risarcimento come quello proposto, parificato al controvalore di un giorno di ingiusta prigionia in carcere, come già impiegato dal Tribunale di Treviso richiamato, ma sarebbe più equo incrementarlo alla somma di euro 400,00 al giorno a valori attuali, perché comunque il trattamento di un internato italiano non aveva le stesse garanzie dei carcerati italiani e gli stessi standard di alimentazione e cura, tantomeno in termini di modalità di utilizzazione della prestazione lavorativa”.
Tale affermazione recepisce una considerazione sostanziale: gli internati non solo furono privati della libertà personale, ma anche esposti a un trattamento disumano sistematico e all’impiego coatto in condizioni di sfruttamento estremo, ben lontane da quelle previste per i detenuti ordinari. Ne consegue che l’assimilazione alla disciplina dell’ingiusta detenzione rappresenta un minimo garantito, spesso suscettibile di rivalutazione in aumento, come dimostrano appunto i casi di Firenze e Genova.
6. Conclusioni: oltre l’indennizzo. l’analogia con l’ingiusta detenzione come strumento per il pieno risarcimento del danno da deportazione
L’analogia con il criterio previsto per l’ingiusta detenzione costituisce oggi il riferimento più solido e coerente per la liquidazione equitativa del danno da deportazione e internamento nei confronti degli IMI.
Tale parametro – ormai richiamato da numerosi Tribunali in tutta Italia – risponde all’esigenza di ancorare la valutazione del danno a un criterio oggettivo, dotato di una base normativa interna e già applicato in contesti affini di privazione della libertà personale.
Tuttavia, è necessario sgomberare il campo da ogni possibile equivoco: se è vero che l’indennizzo previsto per l’ingiusta detenzione rappresenta un utile punto di partenza, esso non può esaurire la portata della tutela dovuta alle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità.
L’ingiusta detenzione, infatti, ha natura indennitaria, come chiarito dalla giurisprudenza penale (Cass. Pen. n. 25359/2023), ed è fondata su principi di solidarietà sociale; al contrario, il danno da deportazione è un danno pienamente risarcibile, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 159/2023[5].
È dunque corretto utilizzare i parametri dell’ingiusta detenzione come base di calcolo, ma a condizione che essi siano letti in chiave dinamica e adattati alle specificità del singolo caso, attraverso aumenti ragionevoli e motivati che tengano conto della durata, delle modalità della cattura, delle condizioni di prigionia, della riduzione in schiavitù e dell’assenza di qualsiasi tutela legale e umanitaria.
In questo senso, la valorizzazione delle circostanze accessorie – come indicato dalla Cassazione penale – permette al giudice civile di operare un apprezzamento equo e calibrato, senza scivolare nell’arbitrarietà.
Infine, non vi è alcun ostacolo normativo al riconoscimento del pieno risarcimento del danno.
Il fondo istituito dall’art. 43, comma 7, del D.L. n. 36/2022 – come confermato dall’Avvocatura dello Stato dinnanzi alla Consulta all’udienza del 04/07/2023, dalla Corte costituzionale stessa e dai lavori parlamentari della norma in rassegna – è strutturato per garantire la soddisfazione integrale dei diritti soggettivi delle vittime, e non per comprimere tali diritti entro limiti di spesa prefissati.
In conclusione, il parametro dell’ingiusta detenzione, se correttamente inteso e applicato, rappresenta non già un limite, ma una soglia di giustizia minima da cui partire per risarcire, in via equitativa ma non simbolica, l’enorme danno esistenziale, psicologico e morale inflitto agli Internati Militari Italiani e a tutti i deportati civili, politici e razziali. La strada verso una giustizia piena passa proprio da qui.
[1] Sulla Corte di Cassazione n. 3642/2024 si veda C. Florean, La Cassazione non scioglie il nodo gordiano sulla prescrizione dei crimini del Terzo Reich https://www.ilcaso.it/articolo/2169
[2] Per un approfondimento alla nozione di fatto notorio in relazione alle condizioni patite dagli IMI si veda Tedoldi - Vantaggiato I risarcimenti agli ex militari internati, Giur. it., giugno 2020 - p. 1390-1399
[3] Così letteralmente il Tribunale di Genova “le predette condizioni di prigionia - praticate nei confronti di tutti i soggetti prigionieri da parte delle forze armate tedesche - risultano essere un fatto storicamente accertato e che va assunto come notorio in difetto di prova contraria, che nel presente giudizio non si rinviene”
[4] In senso contrario si segnala il Tribunale di Roma 02/09/2024, laddove rigettando la domanda per carenza di prova dei patimenti sofferti dall’internato afferma che “Non sono stati addotti testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, durante la prigionia degli IMI indicati in citazione.”
[5] Secondo la sentenza n. 159/2023 della Corte Costituzionale “Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore… Insomma, non c'è un diritto a un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno. Né è previsto un meccanismo di riparto delle somme disponibili, come quello contemplato dall'art. 10 del D.P.R. n. 2043 del 1963 per il calcolo della quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione dell'importo complessivo erogato dalla Germania in esecuzione dell'Accordo di Bonn del 1961…. non c’è più un diritto a un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno (…) è prescritto, invece, un soddisfacimento integrale del credito risarcitorio”.
Scarica Articolo PDF