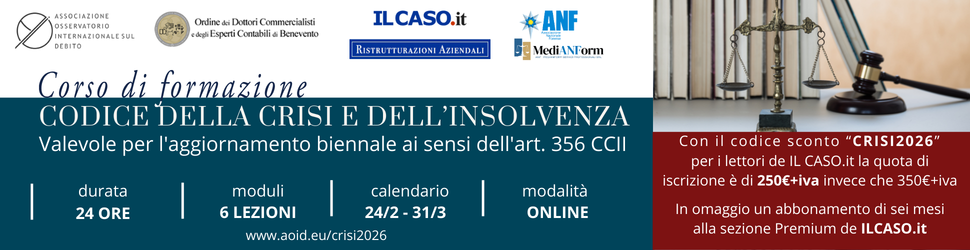Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 04/09/2025 Scarica PDF
Risarcimento per le vittime del Terzo Reich: la Cassazione chiarisce che il MEF non è parte convenuta. Accesso al fondo solo dopo condanna della Germania
Cristina Florean, Avvocato in VeronaSommario: 1. Il caso concreto; 2. L’interpretazione dell’art. 43 D.L. 36/2022 della Cassazione alla luce della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale; 3. La sentenza di condanna della Repubblica Federale di Germania come condizione per l’accesso al Fondo Ristori; 4. Il ruolo processuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 5. L’incidenza dell’eventuale chiamata in giudizio dello Stato italiano; 6. Effetti sistemici della qualificazione del MEF: oltre la sentenza; 7. Conclusioni.
1. Il caso concreto
La vicenda oggetto dell’ordinanza n. 23669 del 21 agosto 2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione[1] trae origine dalla domanda proposta da A.A., in qualità di erede del genitore deceduto, vittima dei crimini di guerra nazisti.
Con atto di citazione del 17 ottobre 2022, A.A. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, la Repubblica Federale di Germania, chiedendone la condanna al risarcimento del danno iure hereditario per i pregiudizi sofferti dal padre, il quale, nel 1944 fu catturato dalle truppe del Terzo Reich, deportato a Monaco di Baviera e ivi ridotto in schiavitù, sottoposto a lavori forzati senza riconoscimento dello status di prigioniero di guerra né delle relative garanzie internazionali.
È intervenuto in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il quale ha sollevato un’eccezione preliminare di incompetenza territoriale, sostenendo che la causa non avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale di Pescara, ma dal Tribunale dell’Aquila, quale foro erariale.
Secondo l’argomentazione svolta dal Ministero, l’eccezione si fondava su due presupposti. In primo luogo, l’entrata in vigore dell’art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito nella L. 29 giugno 2022, n. 79), avrebbe conferito al Ministero la legittimazione ad intervenire nei procedimenti promossi dalle vittime del Terzo Reich, in quanto portatore di un interesse diretto alla sorte della controversia.
In secondo luogo, il MEF ha dedotto che, proprio in ragione di tale legittimazione, la sua partecipazione al giudizio avrebbe comportato l’applicazione delle regole sul foro erariale, ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 6 R.D. n. 1611/1933.
In base alle predette norme, infatti, la competenza spetterebbe al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio – nel caso di specie, individuata nel Tribunale dell’Aquila.
La Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace.
Il Tribunale di Pescara ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale svolta dal MEF, confermando la propria competenza.
Nella motivazione, il giudice di primo grado ha chiarito che l’art. 43 del D.L. 36/2022 disciplina unicamente la fase esecutiva dell’azione risarcitoria, imponendo che le eventuali azioni esecutive avvengano esclusivamente sul Fondo istituito presso il MEF, e non direttamente contro la Germania. Nonostante l’obbligo di notificazione presso l’Avvocatura dello Stato, nulla nella normativa attribuisce legittimazione passiva esclusiva al MEF nelle azioni di accertamento della responsabilità.
Pertanto, il Tribunale ha qualificato l’intervento del MEF come intervento adesivo dipendente, privo di effetti sulla determinazione della competenza, che resta regolata dalle norme ordinarie e non da quelle relative al foro erariale.
Il MEF ha proposto regolamento di competenza, lamentando l’erronea interpretazione dell’art. 43 del D.L. 36/2022 e invocando una propria legittimazione esclusiva.
2. L’interpretazione dell’art. 43 D.L. 36/2022 della Cassazione alla luce della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale
Nel respingere il ricorso del MEF, la Corte di Cassazione ha offerto un’interpretazione sistematica dell’art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022, n. 79), in piena coerenza con quanto già affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 159 del 2023.
La norma in esame ha istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità, commessi dalle forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Tale strumento ha lo scopo di dare continuità all’Accordo di Bonn del 1961.
Come sottolineato dalla Consulta, e ora anche dalla Cassazione, l’art. 43 DL 36/2022 non sostituisce in alcun modo l’ordinaria azione risarcitoria nei confronti della Germania, ma disciplina esclusivamente la fase esecutiva: per ottenere l’accesso al Fondo, è necessario il previo ottenimento di una sentenza passata in giudicato che accerti e liquidi il danno da crimini di guerra. Le sentenze così emesse, in deroga all’art. 282 c.p.c., diventano immediatamente esecutive solo al momento del passaggio in giudicato e danno titolo per escutere esclusivamente il Fondo, non già i beni della Germania.
Di conseguenza, sono precluse le azioni esecutive ordinarie contro lo Stato tedesco.
La Corte costituzionale ha avallato la legittimità costituzionale di tale disciplina, evidenziando che essa dà luogo a un diritto soggettivo pieno e non condizionato, che ha per contenuto il pagamento da parte dello Stato italiano di quanto liquidato in giudizio, con liberazione dell’originario debitore (la Germania). Tale schema realizza una espromissione liberatoria ex lege (art. 1272 c.c.), in quanto trasferisce al Fondo il dovere di adempiere, estinguendo al contempo ogni azione esecutiva già intrapresa o intraprendibile contro lo Stato estero.
Infine, la Corte costituzionale ha opportunamente distinto i profili di giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, rilevando che:
· nei giudizi di accertamento della responsabilità della Germania per crimini internazionali gravi (jure imperii), non opera l’immunità degli Stati, perché essa non può prevalere sul diritto di accesso alla giustizia garantito dall’art. 24 Cost.;
· nei giudizi esecutivi, invece, si applica la regola dell’immunità ristretta, recepita nel nostro ordinamento in base all’art. 10 Cost., che limita la pignorabilità dei beni agli asset destinati ad attività iure gestionis, escludendo quelli collegati a funzioni pubblicistiche[2].
La Cassazione ha quindi confermato che l’art. 43 D.L. 36/2022 non crea una surrogazione del MEF nella legittimazione passiva, né esclude la possibilità di convenire in giudizio la Germania per l’accertamento del danno: l’effetto dell’art. 43 è confinato alla fase esecutiva, mediante il meccanismo del Fondo Ristori, che si attiva solo una volta ottenuta la condanna dello Stato tedesco.
3. La sentenza di condanna della Repubblica Federale di Germania come condizione per l’accesso al Fondo Ristori
Dalla lettura combinata dell’art. 43 D.L. n. 36/2022 e della sentenza della Corte costituzionale n. 159/2023, emerge con chiarezza il principio secondo cui l’accesso al Fondo per il ristoro dei danni causati dai crimini di guerra del Terzo Reich è subordinato all’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti della Repubblica Federale di Germania.
Tale condanna, pronunciata all’esito di un ordinario giudizio di cognizione, costituisce il titolo esecutivo necessario per poter agire sul Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Suprema Corte ribadisce come il meccanismo previsto dall’art. 43 DL 36/2022 non elimina la legittimazione passiva dello Stato tedesco, né esclude la possibilità di instaurare giudizi diretti di accertamento e condanna nei suoi confronti. L’effetto della norma è circoscritto alla fase successiva: quella dell’esecuzione forzata, che può avvenire esclusivamente nei confronti del Fondo, con espresso divieto di promuovere o proseguire procedure esecutive ordinarie contro lo Stato estero.
Questo assetto normativo realizza un bilanciamento costituzionalmente orientato tra il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’art. 24 Cost., che, secondo costante giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 140/2022, 128/2021, 522/2002, 321/1998), si estende anche alla fase esecutiva e il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, in particolare quelli derivanti dall’Accordo di Bonn del 1961, il cui contenuto è riconosciuto come parametro interposto di legittimità costituzionale ex art. 117, primo comma, Cost. (Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007; n. 102 del 2020).
In sintesi, non è possibile accedere al Fondo senza prima aver ottenuto una sentenza di condanna nei confronti della Germania: solo in presenza di tale pronuncia definitiva e irrevocabile il danneggiato potrà agire in executivis nei confronti del Fondo, con esclusione di ogni azione forzata verso lo Stato straniero.
4. Il ruolo processuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Un ulteriore chiarimento offerto dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23669/2025 riguarda la corretta qualificazione del ruolo processuale del MEF nei giudizi di cognizione risarcitori intentati contro la Repubblica Federale di Germania.
La Suprema Corte esclude in modo espresso che l’art. 43, comma 6, del D.L. n. 36/2022, possa essere interpretato nel senso di attribuire al Ministero dell’Economia e delle Finanze una legittimazione passiva esclusiva, in sostituzione dello Stato estero. Tale comma prevede che, per i giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, l’atto introduttivo debba essere notificato presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 144 c.p.c.
Secondo la Cassazione tale disposizione ha funzione meramente strumentale: serve a rendere edotto lo Stato italiano (per esso, il MEF) dell’instaurazione del giudizio, così da consentirgli, ove ritenuto opportuno, di intervenire nel processo, non certo per sostituirsi al convenuto legittimo, che resta la Repubblica Federale di Germania.
In questa prospettiva, il MEF non assume la qualità di parte convenuta, ma può intervenire ad adiuvandum, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., per sostenere le ragioni dello Stato estero, avendo un proprio interesse diretto all’esito del giudizio, in quanto chiamato a rispondere nella fase esecutiva in caso di condanna.
A conferma di ciò, la Corte richiama le stesse deduzioni del MEF nel giudizio di primo grado, dove, l’Amministrazione si è espressamente qualificata come interventore volontario[3]. Soltanto nel successivo ricorso per regolamento di competenza il Ministero ha tentato una riconfigurazione del proprio ruolo processuale, nel senso di essere l’unico legittimato passivo, ma tale ricostruzione è stata rigettata in quanto infondata.
Infine, la Corte ribadisce un principio processuale rilevante in materia di competenza: l’intervento volontario di una pubblica amministrazione non comporta l’applicazione del foro erariale, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme nei casi di intervento volontario, come quello qui in esame. Ne consegue che il foro competente resta quello determinato in base alle regole ordinarie, non essendo il MEF una parte necessaria del giudizio[4].
5. L’incidenza dell’eventuale chiamata in giudizio dello Stato italiano
Nel ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione assume rilievo la distinzione tra il caso oggetto dell’ordinanza e un’altra, differente fattispecie esaminata dalla stessa Terza Sezione con la pronuncia del 19 marzo 2025, n. 7371.
In quest’ultima ipotesi, la domanda risarcitoria per i danni da crimini di guerra era stata proposta non solo nei confronti della Repubblica Federale di Germania, ma anche contro lo Stato italiano, nella persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In tale contesto, la costituzione volontaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze – con cui quest’ultimo rivendicava la propria esclusiva legittimazione passiva – non fu qualificata come intervento adesivo (ex art. 105 c.p.c.), bensì come costituzione di parte legittimamente evocata, integrando così un effetto sanante dell’errata individuazione originaria della parte nel giudizio, secondo i principi di cui all’art. 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2018, n. 30649).
Questa diversa configurazione soggettiva della parte convenuta ha effetti rilevanti in tema di competenza.
Diversamente dal caso deciso dall’ordinanza in commento, dove l’intervento del MEF non incide sulla competenza per essere meramente adesivo, mentre nella pronuncia n. 7371/2025, l’evocazione in giudizio di un’amministrazione dello Stato (come parte originaria) ha comportato l’applicazione del foro erariale.
Infatti, nei casi in cui vi sia cumulo soggettivo di domande contro un’amministrazione dello Stato e contro un soggetto terzo (in questo caso, lo Stato estero), trova applicazione la competenza inderogabile del foro erariale, che risulta prevalente, ai sensi dell’art. 25 c.p.c. e dell’art. 6 R.D. n. 1611/1933.
Nel caso oggetto dell’ordinanza 7271/2025, la competenza fu individuata nel Tribunale di Roma, quale sede della Direzione dei Servizi del Tesoro, competente in via esclusiva, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 28 giugno 2023, per l’erogazione dei ristori tramite la tesoreria centrale.
Questa configurazione processuale ha anche una ricaduta sostanziale: la presenza in giudizio di un’amministrazione statale formalmente convenuta determina l’estensione formale della decisione resa sulla domanda proposta contro la Germania anche a quest’ultima, in quanto titolare della posizione giuridica dipendente dal riconoscimento della responsabilità dello Stato estero.
Come ha evidenziato la Corte, questo è possibile in base al principio di legittimazione alternativa tra intervento adesivo dipendente (ex art. 105 c.p.c.) e chiamata diretta in giudizio del titolare della posizione dipendente.
In altre parole, la parte lesa può dunque scegliere se convenire direttamente anche l’amministrazione italiana, provocando effetti sul piano della competenza e dell'estensione della decisione, oppure limitarsi a convenire la Germania, con il MEF che potrà intervenire volontariamente, ma senza alterare il quadro della competenza territoriale né incidere sull’oggetto principale della lite.
6. Effetti sistemici della qualificazione del MEF: oltre la sentenza
Come affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23669/2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per crimini di guerra, non assume la qualità di parte convenuta, ma può esclusivamente intervenire in giudizio ad adiuvandum, in sostegno della Repubblica Federale di Germania, in qualità di interventore adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.
Questa qualificazione, che segna il confine netto tra la responsabilità risarcitoria della Germania (quale unica parte legittimata passiva nel giudizio di cognizione) e l’impegno economico assunto dallo Stato italiano nella sola fase esecutiva, comporta una serie di conseguenze rilevanti sul piano processuale, che la stessa Corte ha avuto modo di chiarire in termini sistematici.
Il primo effetto diretto e immediato che ne deriva riguarda il profilo della competenza territoriale.
La sola partecipazione del MEF al giudizio, in qualità di interventore volontario, non comporta lo spostamento della causa al foro erariale. La regola posta dall’art. 7 del R.D. n. 1611/1933 è chiara: l’intervento volontario di un’amministrazione statale non ha rilevanza ai fini della determinazione della competenza.
Pertanto, se il MEF non è stato convenuto sin dall’origine, ma ha ricevuto esclusivamente la notifica dell’atto introduttivo (come previsto dal comma 6 dell’art. 43 del D.L. 36/2022), la competenza continua a determinarsi secondo i criteri ordinari, come il forum commissi delicti o il foro della sede italiana del convenuto estero.
A partire dalla qualificazione del MEF quale intervenuto adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. si delineano, in via sistematica, ulteriori conseguenze giuridiche e processuali, non esplicitamente affermate dalla Cassazione nella pronuncia in esame, ma coerenti con la natura stessa dell’intervento adesivo dipendente.
Anzitutto, deve escludersi qualsiasi forma di successione o di responsabilità solidale tra la Germania e lo Stato italiano.
L’art. 43 del D.L. 36/2022 non ha in alcun modo modificato la titolarità del rapporto giuridico controverso. La responsabilità per i danni derivanti da crimini di guerra continua a gravare interamente sulla Repubblica Federale di Germania, mentre lo Stato italiano ha assunto unicamente l’onere economico legato all’esecuzione delle sentenze di condanna, attraverso un meccanismo che si attiva solo dopo il passaggio in giudicato (Corte cost. n. 159/2023). Si tratta, dunque, di una traslazione meramente patrimoniale nella fase attuativa, che non incide sul piano sostanziale della responsabilità.
Ne consegue, in modo coerente, che il MEF non riveste il ruolo di litisconsorte necessario.
Non si è in presenza di un rapporto plurisoggettivo inscindibile ai sensi dell’art. 102 c.p.c., né vi è la necessità di chiamare il MEF in causa per assicurare l’efficacia della sentenza.
Il titolo esecutivo idoneo per l’accesso al Fondo resta la sentenza passata in giudicato di condanna pronunciata nei confronti della sola Germania, senza alcun obbligo di coinvolgere lo Stato italiano nella fase cognitiva.
In questa prospettiva, il MEF, in quanto interventore adesivo dipendente, non può esercitare poteri dispositivi nel processo.
La sua attività si esaurisce nel sostegno alle difese della parte principale — ossia della Germania — e non può estendersi alla proposizione di domande autonome o eccezioni in senso stretto (sul punto, si vedano Cass. Civ. Sez, Un n. n. 23299/2011; Cass. Civ. 29355/2018; Cass. Civ. 24806/2022; Cass. civ. nn. 17595/2004; 24370/2006), come ad esempio quella di prescrizione.
La stessa ordinanza in commento, pur concentrandosi sull’aspetto della competenza territoriale, si muove nel solco di tale ricostruzione, affermando l’estraneità del MEF alla titolarità del rapporto sostanziale.
Ciò comporta anche che l’interventore adesivo non è legittimato, di regola, a proporre impugnazione.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con la sentenza n. 32559/2023 – hanno riaffermato un principio ormai consolidato: l’interventore adesivo non può autonomamente impugnare una decisione sfavorevole se la parte adiuvata (nel caso di specie, la Germania) non abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione o vi abbia rinunciato, «salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento». La pronuncia richiama, in tal senso, un orientamento giurisprudenziale costante (Cass. nn. 2818/2018, 27528/2016, 16930/2013, SU n. 5992/2012), che sottolinea il carattere ancillare e subordinato della posizione processuale dell’interventore.
Va tuttavia riconosciuto al MEF un interesse giuridico concreto a intervenire in giudizio, interesse che trova fondamento nella sua posizione eventuale di soggetto tenuto a sopportare, in fase esecutiva, le conseguenze economiche di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Germania.
Si tratta dunque di un interesse effettivo e non meramente fattuale, che giustifica l’intervento ai sensi dell’art. 105 c.p.c., ma che non è sufficiente a conferire al MEF la qualità di parte processuale in senso proprio.
Questa distinzione è rafforzata dal ruolo che il MEF assume nella fase post-giudiziale, come disciplinato dal decreto attuativo del 28 giugno 2023.
Tale decreto attribuisce al Ministero poteri istruttori significativi nella gestione del Fondo Ristori: tra questi vi sono la verifica della titolarità del diritto al ristoro, il controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la possibilità di rigettare la richiesta di accesso in presenza di cause ostative. Tuttavia, questi poteri si esercitano esclusivamente dopo la formazione del giudicato, e non incidono in alcun modo sull’accertamento del diritto in sede cognitiva. Un’eventuale partecipazione del MEF come parte del processo di cognizione determinerebbe una commistione indebita tra poteri amministrativi e funzione giurisdizionale, in violazione dei principi di separazione delle fasi processuali e del giudicato ex art. 2909 c.c.
Come chiarito dalla Cassazione, quindi, l’obbligo di notifica all’Avvocatura dello Stato previsto dal comma 6 dell’art. 43 non può essere inteso come titolo legittimante alla partecipazione automatica del MEF al processo.
La norma si limita a imporre un adempimento informativo, volto a garantire che l’amministrazione competente sia messa a conoscenza della pendenza del giudizio, ma non individua una specifica amministrazione da evocare in giudizio, né tantomeno impone o autorizza la costituzione del MEF come parte.
In definitiva, la qualificazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze come interventore adesivo dipendente, e non come parte convenuta, non rappresenta una scelta meramente formale, ma riflette un equilibrio sistemico preciso, coerente con la volontà del legislatore di separare il piano della responsabilità giuridica (rimasta in capo alla Germania) da quello del ristoro patrimoniale (assunto dallo Stato italiano nella fase esecutiva).
In questo modo si garantisce, da un lato, il rispetto degli obblighi internazionali e, dall’altro, l’effettività della tutela giurisdizionale delle vittime, senza snaturare l’assetto del processo civile né alterare le regole sulla competenza, sull’efficacia del giudicato e sul ruolo delle parti.
7. Conclusioni
L’ordinanza n. 23669 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un passaggio chiarificatore di rilievo nel complesso contesto dei giudizi risarcitori promossi nei confronti della Repubblica Federale di Germania per i crimini di guerra e contro l’umanità commessi durante il secondo conflitto mondiale. Con questa pronuncia, la Corte non solo affronta un nodo interpretativo rilevante, ma fornisce un quadro sistematico utile a orientare la prassi giudiziaria.
Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della Germania, nonostante l’entrata in vigore dell’art. 43 del D.L. n. 36/2022. L’istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all’accertamento, a titolo di attuazione del giudicato.
Altro profilo chiarito dalla Corte è che l’accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, divenuta definitiva. Non è sufficiente l’accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano. Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento.
Fondamentale è poi la qualificazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze come interventore adesivo dipendente ai sensi dell’art. 105 c.p.c. Il MEF può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del Fondo; non assume, dunque, la posizione di parte in senso proprio nel giudizio di cognizione, né può esercitare poteri dispositivi come la proposizione di domande o l’eccezione di prescrizione.
Da questi tre capisaldi discendono conseguenze operative tutt’altro che marginali. Sul piano della competenza territoriale, la causa resta incardinata secondo i criteri ordinari, fintanto che non venga convenuta anche un’amministrazione statale. E ancora, sul fronte processuale, la partecipazione del MEF non è idonea a incidere sull’oggetto del giudizio né a legittimare eccezioni in senso stretto.
Nel loro complesso, i chiarimenti offerti dalla Cassazione risultano perfettamente allineati con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 159/2023, contribuendo a definire in modo coerente il perimetro del nuovo assetto normativo. Ne emerge una visione ordinata e sistematica in cui lo Stato italiano, pur chiamato a farsi carico delle conseguenze economiche di una condanna pronunciata nei confronti della Germania, resta esterno al processo di formazione del giudicato, riaffermando così la centralità del giudizio di cognizione nei confronti dell’unico soggetto giuridicamente responsabile: la Repubblica Federale di Germania.
[1] In questa Rivista, https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/33500
[2] Sulla Corte Costituzionale n. 159/2023 si veda W. BISSOLI e C. FLOREAN La storia infinita dei risarcimenti danni per i crimini nazisti: la sentenza della Corte costituzionale n. 159/2023, https://blog.ilcaso.it/news_2160/28-01-24/La_storia_infinita_dei_risarcimenti_danni_per_i_crimini_nazisti-_la_sentenza_della_Corte_costituzionale_n__159-2023
[3] Tale posizione, peraltro, è stata sostenuta dall’Avvocatura di Stato anche innanzi alla Corte costituzionale (sent. 159/2023), laddove ha espressamente affermato che nei giudizi di accertamento e condanna proposti nei confronti della Repubblica federale tedesca, sia intervenuta volontariamente in giudizio, in vista dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali.
[4] Secondo l’interpretazione dell’art. 43 DL 36/2022 data dalla Consulta con la sentenza n. 159/2023 e dalla presente ordinanza della Corte di Cassazione, quindi, la sentenza emessa nei soli confronti della Germania è pienamente efficace e titolo idoneo per l’accesso al Fondo di cui all’art. 43 D.L. 36/2022.
Scarica Articolo PDF