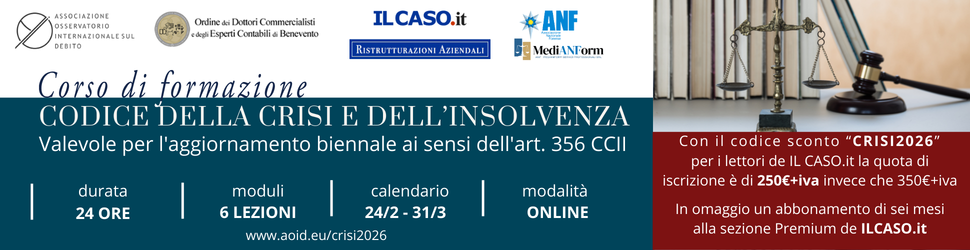Persone
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 11/09/2025 Scarica PDF
Demenza senile e Alzheimer: la permanenza in RSA può essere gratuita?
Tomas Schena, Praticante avvocatoSommario: 1. Premessa. – 2. Le disposizioni normative in materia di prestazioni socio-assistenziali. – 3. L’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale – 4. La restituzione delle somme corrisposte. – 5. La dimensione economica del problema.
1. Premessa.
Il diritto alla salute costituisce uno dei principi cardine del nostro ordinamento: dall’art. 32 della Costituzione è riconosciuto come diritto fondamentale ed essenziale per ogni essere umano. Tale diritto non si limita solo e unicamente all’accesso alle cure mediche, ma comprende altresì la prevenzione, l’assistenza, la riabilitazione e la protezione di condizioni di vita adeguate e umane per ogni persona.
Il compito che viene assegnato allo Stato e al Servizio Sanitario Nazionale è di provvedere e garantire l’equità, l’universalità e l’uguaglianza di accesso ai servizi.
In questo contesto, un numero sempre crescente di persone affette da gravi patologie, come nel caso specifico l’Alzheimer, necessita di ricovero presso strutture RSA, con conseguenti costi di degenza che spesso ricadono sui familiari più prossimi o sull’amministratore di sostegno, qualora sia stato nominato.
Pertanto,quando una persona affetta da Alzheimer o da demenza senile viene ricoverata in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) comunale o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, l’ente può richiedere al malato o ai suoi familiari il pagamento, totale o parziale, della retta di degenza?
2. Le disposizioni normative in materia di prestazioni socio-assistenziali.
Cronologicamente, il riferimento normativo iniziale è rappresentato dalla Legge 27 dicembre 1983 n. 730, il cui art. 30 prevede che: «Per l’esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate».
Una prima definizione di tali attività si rinviene nel D.P.C.M. 8 agosto 1985, all’art. 1, il quale stabilisce che: «Le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali di cui all’art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l’attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti».
Vi è poi il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che all’art. 3, comma 3, sancisce che: «Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie […] tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. […] Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza».
Detto decreto, unitamente al D.P.C.M. 29 novembre 2001, ha tentato di classificare le prestazioni in tre categorie:
1. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, a carico delle ASL;
2. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, a carico dei Comuni, con compartecipazione dell’utente;
3. prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, a carico del Fondo Sanitario Nazionale.
In quest’ultima categoria rientrano le cure per soggetti malati di Alzheimer o demenza grave, laddove le necessità terapeutiche siano intense, complesse e non riducibili a mera assistenza.
Ciò si evince anche nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che sostituisce il primo, ed in cui si legge, all’art. 53, che: «Le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti individuate dall’allegato 8 al presente decreto hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo»; allegato in cui è presente quale malattia cronica ed invalidante l’Alzheimer (codice esenzione 029).
3. L’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale.
Nell’ambito del descritto panorama normativo, la sentenza c.d. apripista è senza dubbio una decisione[1] di legittimità risalente all’anno 2012, con la quale la Suprema Corte ha introdotto un principio di svolta: qualora il ricovero comporti prestazioni sanitarie indispensabili, l’onere della retta deve essere integralmente sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Di conseguenza, né il paziente né i suoi familiari possono essere chiamati a farsi carico delle relative spese, né il Comune può rivalersi su di loro.
In concreto, ciò significa che, per poter ottenere l’esonero dal pagamento della retta (o, qualora questa sia già stata corrisposta, il rimborso delle somme indebitamente richieste dagli enti), è necessario che, accanto alle prestazioni di tipo socio-assistenziale, siano erogate anche quelle di natura sanitaria, le quali devono rappresentare il nucleo centrale dell’intervento rivolto al soggetto ricoverato.
Trattandosi di principi tutelati dal presidio costituzionale dell’art. 32, la Corte ha precisato che «l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde».
Ne consegue che, laddove le prestazioni sanitarie non possano essere erogate “se non congiuntamente” a quelle socio-assistenziali, rendendo impossibile distinguere i rispettivi oneri economici, deve riconoscersi la prevalenza della natura sanitaria del servizio. Le prestazioni assistenziali, infatti, devono essere considerate strettamente strumentali e funzionali alle prime, concorrendo a formare una “complessiva prestazione” che, in quanto inscindibile ed integrata, deve essere garantita a titolo gratuito.
Più recentemente, il Supremo Collegio[2] ha nuovamente ribadito che non è possibile distinguere le prestazioni sanitarie fornite dalla struttura dalla componente alberghiero-assistenziale, in quanto il criterio applicabile resta quello «della integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l’integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale».
Di conseguenza, nella valutazione dell’eventuale discrimine tra le diverse tipologie di prestazioni, il parametro di riferimento non deve essere la natura della struttura di ricovero, bensì le effettive condizioni del paziente. Occorre dunque verificare se il piano terapeutico personalizzato risulti realmente indispensabile «in relazione alla patologia della quale risultava affetto (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l’aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l’evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente dannosi per i terzi».
Tale principio è stato recepito in diverse pronunce anche dalla giurisprudenza di merito.
A titolo esemplificativo, si rileva che il Tribunale di Monza[3] ha affermato che i pazienti affetti da demenza senile in fase avanzata hanno diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni erogate, trattandosi di interventi socio-sanitari ad elevata integrazione, nei quali la componente sanitaria risulta prevalente, ribadendo che la necessità di trattamenti sanitari continuativi comporta l’obbligo del SSN di sostenere integralmente la retta, a prescindere dal fatto che la struttura non sia formalmente ospedaliera.
Significativa è poi la pronuncia del Tribunale di Firenze del 2018, la quale ha invece escluso la configurabilità di un rapporto privatistico di tipo contrattuale, sottolineando che si tratta di un servizio pubblico sanitario ed in tale prospettiva, ha affermato che l’onere economico deve essere suddiviso per il 50% a carico del SSN regionale e per il restante 50% a carico del Comune[4].
Ci sono, tuttavia, pronunce più datate, anche di legittimità, che si orientano in senso opposto.
La Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare[5] che gli enti del servizio sociosanitario residenziale erogano «una prestazione di servizio (assistenza sanitaria obbligatoria), di contenuto predeterminato, in favore del soggetto cui è assicurata ex lege la tutela della salute, affidata al Servizio sanitario pubblico, alle condizioni quali-quantitative ed anche tariffarie determinate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali in base alle risorse finanziarie disponibili, condizioni e tariffe che detta struttura è tenuta ad accettare se intende svolgere tale attività» e che, per le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, è possibile limitare l’intervento nella spesa pubblica alla sola parte sanitaria della prestazione che, in quanto non distinguibile sul piano dei singoli servizi erogati, è stata individuata “forfetariamente” in termini percentuali pari alla metà dell’importo del costo complessivo[6].
Tuttavia, tale orientamento pare del tutto superato dalle pronunce successive: diversi provvedimenti della Suprema Corte[7] e da ultimo anche una recente sentenza[8] dell’anno 2024, in ossequio al criterio della integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce l’integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale (ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, art. 3, comma 3), ha statuito che: «le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del SSN quando risulti, in base ad una valutazione operata in concreto, che tenga conto […] della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all’interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale. Si tratta in tali casi di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente all’attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie»[9].
4. La restituzione delle somme corrisposte.
Benché l’orientamento della giurisprudenza di legittimità risulti oggi consolidato, occorre precisare che – come spesso accade quando il cittadino è “a credito” (e mai quando egli è “a debito”) – non sussiste alcun automatismo: il paziente, o chi lo rappresenta, non può quindi sic et simpliciter sottrarsi legittimamente al pagamento della retta.
La possibilità di escludere tale obbligo deve essere valutata dal Giudice caso per caso.
Ne consegue la necessità di adire il Tribunale competente per richiedere la ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., ossia il rimborso delle somme non dovute, entro il termine di prescrizione decennale.
L’azione può essere promossa direttamente dal paziente, qualora capace, oppure dal tutore o dall’amministratore di sostegno; in alternativa, vi possono ricorrere i familiari, se sono stati loro a sostenere le spese.
Il giudizio deve essere instaurato nei confronti della struttura sanitaria, producendo in allegato la documentazione clinica, l’autorizzazione al ricovero in RSA, la dichiarazione di soggiorno, le ricevute dei pagamenti, eventuali piani terapeutici personalizzati e, se necessario, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per accertare la natura delle prestazioni erogate.
5. La dimensione economica del problema.
A seguito del consolidarsi del discusso orientamento giurisprudenziale, è così emersa la reale portata del problema, che non è soltanto umana e sociale, ma anche economica.
La retta mensile per il ricovero in RSA ammonta infatti alla “modica” cifra di circa duemila euro per persona.
Secondo i dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia oltre un milione di persone è affetto da patologie neurodegenerative, di cui circa 600.000 da Alzheimer[10].
Attorno a questi pazienti gravitano quasi tre milioni di familiari e caregiver, frequentemente lasciati soli ad affrontare un carico assistenziale, emotivo ed economico sempre più gravoso e difficilmente sostenibile.
È stato dunque stimato che, qualora il Servizio Sanitario Nazionale dovesse sostenere integralmente i costi di ricovero di tutti i malati di Alzheimer e demenza, la spesa complessiva supererebbe i 10 miliardi di euro l’anno.
Attualmente, in Italia si contano circa 300.000 posti letto nelle RSA, destinati in prevalenza a persone molto anziane, con età superiore agli 85 anni e affette da tre o più comorbilità[11].
Si tratta di un’utenza diversa, per caratteristiche anagrafiche e cliniche, rispetto a quella che usufruisce dell’assistenza domiciliare, rivolta principalmente a ultrasettantacinquenni con patologie croniche meno numerose e in fase meno avanzata.
In questi casi, infatti, la modalità di presa in carico domiciliare risulta più appropriata e funzionale, poiché richiede un livello assistenziale di minore complessità.
Secondo i dati ISTAT, la popolazione anziana ha ormai superato un quarto del totale degli italiani, con oltre il 7% costituito da ultrasettantacinquenni, pari a più di 4 milioni di persone. Ne deriva che una quota ristretta della popolazione, pari a circa l’1%, potrebbe arrivare da sola ad assorbire fino a un terzo della spesa sanitaria nazionale[12].
Sul piano giurisprudenziale, le citate pronunce hanno stabilito che il ricovero in RSA per anziani non autosufficienti debba gravare interamente sul Servizio Sanitario Nazionale. Pur prendendo avvio da casi riguardanti pazienti affetti da Alzheimer, i principi interpretativi individuati – fondati sull’inscindibilità tra prestazioni sanitarie e assistenziali o sulla prevalenza delle prime rispetto alle seconde – risultano applicabili alla quasi totalità dei ricoveri. In tutti i casi, l’esito è quello di ricondurre l’intero costo del ricovero nell’ambito delle competenze del SSN.
Se davvero il Fondo Sanitario Nazionale dovesse sostenere integralmente tutte le rette di ricovero in RSA, la spesa aumenterebbe di oltre 10 miliardi di euro annui. Inoltre, qualora si volesse raggiungere la media di posti letto garantiti in altri Paesi europei, il fabbisogno crescerebbe fino a oltre 20 miliardi di euro.
Sul punto occorre considerare che il Fondo Sanitario Nazionale dispone oggi di circa 120 miliardi, destinati non solo alle prestazioni ospedaliere, riabilitative, ambulatoriali e territoriali, ma anche alla spesa farmaceutica, che da sola assorbe circa la metà delle risorse complessive[13].
Pertanto, destinare 20 miliardi esclusivamente ai ricoveri in RSA significherebbe allocare un terzo dell’intera spesa sanitaria – al netto della farmaceutica – per una fascia ristretta di popolazione ultraottantacinquenne, che rappresenta meno dell’1% del totale degli italiani.
Sul tema, lo scorso marzo la maggioranza ha presentato in Senato un emendamento “salva-RSA”, che prevedeva di porre nuovamente a carico dei cittadini una parte dei costi delle rette. Il provvedimento, dopo aver ottenuto l’approvazione in Commissione Sanità, è stato tuttavia respinto dalla Commissione Bilancio[14].
Considerata la spinta legislativa in atto e l’eventualità di una revisione dell’orientamento giurisprudenziale finora consolidato, è ragionevole ritenere che le iniziative giudiziarie che oggi potrebbero trovare pieno accoglimento possano in futuro sortire esiti differenti, sicché appare opportuno avviarle con tempestività.
[1] Cass., 22 marzo 2012, n. 4558.
[2] Cass., 18 maggio 2023, n. 13714.
[3] Trib. Monza, 1° marzo 2017, n. 617 in Banca dati di merito – Ministero della Giustizia.
[4] Trib. Firenze, 5 aprile 2018, n. 1010 in Banca dati di merito – Ministero della Giustizia.
[5] Cass., 28 novembre 2017, n. 28321.
[6] Cass., 13 novembre 2019, n. 29334.
[7] Ex multis cfr. Cass.11 dicembre 2023, n. 34590; Cass. 4 settembre 2023, n. 25660; Cass. 22 febbraio 2024, n. 4752.
[8] Cass. 29 luglio 2024, n. 21162
[9] Tale impostazione è stata da ultimo recepita da App. Milano, 9 giugno 2025.
[10] Cfr. www.epicentro.iss.it/demenza/2020-2024 (ultimo controllo eseguito in data 10 settembre 2025).
[11] Si v. www.istat.it/comunicato-stampa/le-strutture-residenziali-socio-assistenziali-e-socio-sanitarie-anno-2023/ (ultimo controllo eseguito in data 10 settembre 2025).
[12] I dati sono tratti dalla pagina web seguente: www.istat.it/it/files/2024/05/Sintesi-Rapporto-Annuale-2024.pdf, p. 11 (ultimo controllo eseguito in data 10 settembre 2025).
[14] Trattasi dell’emendamento n. 13.0.400 al Ddl 1241, presentato in data 23 settembre 2024, che mirava a definire meglio i criteri di gratuità delle prestazioni sociosanitarie nelle RSA, ma è stato bocciato in Commissione Affari Sociali l'11 aprile 2025; per ulteriori dettagli cfr. www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58536.
Scarica Articolo PDF