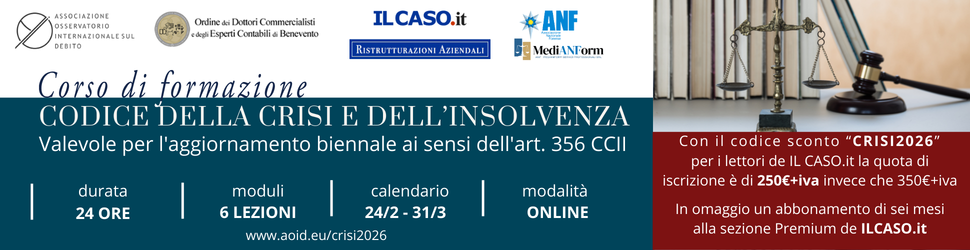Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 10/11/2025 Scarica PDF
Le procedure familiari nella gestione delle crisi da sovraindebitamento (note intorno all’art. 66 CCII)
Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedre di Diritto Fallimentare delle Università Milano - Bicocca e PerugiaSommario: 1. Le procedure familiari 2. Ambito di applicazione della norma 3. Nozione di famiglia 4. La struttura dell’art. 66 CCII 4.1. La domanda unitaria di accesso (primo comma) 4.2. Pluralità di domande distinte (quarto comma) 5. Requisiti soggettivi: qualificazione eterogenea dei familiari 6. Qualificazioni eterogenee dei familiari e procedura unitaria: quale disciplina applicabile? 6.1. Profili di inammissibilità riguardanti il singolo familiare ricorrente 6.2. Revoca dell’omologazione per fatto del singolo familiare ricorrente
1. Le procedure familiari
Le procedure familiari - codificate all’art. 66 CCII nell’unico articolo ed esse dedicate dal Codice della Crisi, rubricato appunto “Procedure familiari” - rappresentano un tema di particolare interesse per lo studioso degli strumenti del sovraindebitamento, per almeno tre ragioni:
§ l’art. 66 CCII è contenuto nelle “Disposizioni di carattere generale” del Capo II del Titolo IV delle procedure di sovraindebitamento, per cui la disciplina delle procedure familiari è declinabile nelle tre diverse procedure ‘minori’ e nell’esdebitazione dell’incapiente, atteggiandosi diversamente a seconda dello strumento cui accede;
§ la norma ha un’indubbia valenza sistematica: essa interferisce, al contempo, con le disposizioni di carattere sostanziale delle procedure di sovraindebitamento e con le norme processuali contenute nella disciplina generale sulla competenza, di cui agli artt. 29 ss. CCII;
§ l’istituto delle procedure familiari è uno dei pochi strumenti anticipati dalla riforma entrata in vigore il 25.12.2020 (l.176/2020), quando il legislatore ha ritenuto di contenere gli effetti sociali della pandemia innestando nella legge 3/2012 alcune previsioni del Codice della Crisi, tra cui appunto le procedure familiari codificate all’art. 7-bis l. 3/2012 creato ex novo: malgrado il carattere stringato della norma e le criticità emerse, esse hanno passato un più ampio vaglio giurisprudenziale, anche alla luce del quale il legislatore è intervenuto con le modifiche apportate dal Correttivo-Ter.
2. Ambito di applicazione della norma
Curiosamente, sia l’art.7-bis l. 3/2012 che l’art. 66 CCII hanno ingenerato alcune perplessità circa l’ambito di applicazione delle procedure familiari agli strumenti della crisi da sovraindebitamento.
L’art. 7-bis, infatti, era stato inserito nella Sezione Prima della l. 3/2012, che regolava solo il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti, non anche la liquidazione del patrimonio contenuta nella Sezione Seconda, per cui una prima giurisprudenza aveva escluso l’ammissibilità della domanda congiunta di familiari avente ad oggetto l’istanza di apertura della procedura liquidatoria[2].
Analogamente, l’art. 66 CCII evidenzia uno disallineamento tra le tre procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII: il primo comma dispone che “I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’art. 65, comma 1 […]”, mentre l’art. 65, comma 1, CCII, esclude espressamente il richiamo all’esdebitazione dell’incapiente, stabilendo che “I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX”, ove lo strumento dell’esdebitazione ex art. 283 CCII è, appunto, regolato al capo X, non al capo IX, quest’ultimo dedicato solo alla liquidazione controllata[3].
3. Nozione di famiglia
Fino all’introduzione dell’art.66 CCII, e prima ancora dell’art. 7-bis l.3/2012, la famiglia veniva in evidenza solo incidentalmente nel diritto concorsuale, con disposizioni quali
i. quella a tutela delle esigenze di mantenimento del nucleo, per cui il Giudice determina l’importo necessario a tal fine come limite di mantenimento del debitore “e della sua famiglia”, ex art. 268, comma 4, lett. b);
ii. la norma che salvaguarda l’immobile posto in fondo patrimoniale a tutela dei bisogni della famiglia, escluso dalla liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. c);
iii. infine, la disposizione ex art. 47 l. fall., oggi 147 CCII, che al primo comma prevede il sussidio in favore del debitore per quanto necessario “a titolo di alimenti per lui e per la famiglia”, mentre al secondo comma garantisce il godimento della casa di abitazione fino all’aggiudicazione, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione “di lui e della famiglia”.
L‘art. 9 della legge delega del 2017, invece, aveva imposto al legislatore delegato un intervento più organico a tutela della famiglia, ovvero di “individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure di sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia”, sul presupposto di un fenomeno empirico riscontrato con grande frequenza: il verificarsi della propagazione dell’insolvenza del debitore ai membri della famiglia, nelle fattispecie classiche rappresentate dal mutuo cointestato sull’abitazione, dalla coobbligazione derivante dal rilascio di garanzia al sistema bancario al fine di sorreggere l’impresa di un familiare, od ancora, dalla vicenda, tutt’altro che infrequente, della successione ereditaria nei debiti del de cuius.
Nel comma 2 il legislatore definisce i “membri della stessa famiglia”, per cui si considerano tali “ai fini del comma 1, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”.
La prassi ha evidenziato, peraltro, che le esigenze di trattazione unitaria della crisi da sovraindebitamento riguardano anche i divorziati o gli ex conviventi, dopo lo scioglimento dell’unione civile o della stabile convivenza; in tal senso, poteva ipotizzarsi un intervento del legislatore, in sede di Correttivo Ter, volto ad ampliare il perimetro soggettivo di operatività delle procedure familiari, almeno ogniqualvolta si fosse in presenza del requisito dell’origine comune del sovraindebitamento.
La giurisprudenza sembra orientata ad interpretazioni restrittive; se non osta al ricorso unitario ex art. 66 CCII la condizione di coniugi non conviventi in quanto separati legalmente (cfr. Trib. Forlì 19 gennaio 2024), viene invece ritenuta inammissibile la domanda congiunta proposta da debitori divorziati, appunto “per assenza del presupposto ex art. 66, comma 2, CCII” (Trib. Bologna 19 novembre 2024)[4].
4. La struttura dell’art. 66 CCII
L’art. 66 si compone di 5 commi.
Fatta eccezione per l’ultimo comma, che regola il compenso dell’OCC su cui è opportunamente intervenuto il Correttivo Ter chiarendo che esso è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno, non in base all’ammontare dei debiti, appare subito chiaro che:
- i primi tre commi sono riferiti alla domanda unitaria di accesso e regolano i requisiti soggettivi e oggettivi, codificando anche la regola della distinzione delle masse attive e passive di ciascun ricorrente;
- il quarto comma è più spiccatamente processuale e regola il caso in cui sono presentate più domande autonome e distinte da parte di membri della stessa famiglia.
Quindi la norma distingue la domanda unitaria di accesso (comma 1) dalla pluralità di domande presentate dai singoli familiari, per le quali sussistono evidentemente esigenze di coordinamento, a maggior ragione ove esse risultino proposte presso diversi fori(comma 4).
Si riproduce qui di seguito l’articolo in commento con le modifiche, segnalate in rosso, apportate dal Correttivo Ter.
4.1. La domanda unitaria di accesso (primo comma)
I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. […]
Il Correttivo Ter ha opportunamente sostituito l’inciso “un unico progetto di risoluzione della crisi” con “un’unica domanda di accesso”, abbandonando una formula attinente più al contenuto della domanda che non all’atto di instaurazione della procedura.
La disposizione pone due requisiti alternativi tra loro, rappresentati dalla convivenza e dall’origine comune del sovraindebitamento, in presenza dei quali più familiari ricorrenti possono depositare un unico ricorso introduttivo dell’unica procedura ‘di gruppo’, per il tramite di un Gestore della crisi unico per tutti, nominato dal competente OCC[5].
La prassi ha, peraltro, evidenziato che il carattere unitario della procedura cede il passo al principio di distinzione delle masse attive e passive di ciascun ricorrente, codificato al terzo comma, che porta con sé una serie di corollari, il primo dei quali sostanzialmente impone di non derogare alle regole fondamentali codificate all’art. 2740 c.c. (garanzia patrimoniale generica) e all’art. 2741 c.c. (principio dell’ordine delle cause legittime di prelazione).
Vediamo dunque come si declina detto principio nelle varie procedure.
a) In riferimento alla liquidazione controllata si osserva in primo luogo, come emerge dalla prassi, che la domanda unitaria di accesso non impedisce che la cancelleria apra distinti fascicoli processuali assegnando un diverso numero di ruolo alla procedura di ciascun ricorrente.
Il carattere unitario della domanda consente al Tribunale di nominare un unico liquidatore per tutti i familiari ricorrenti, ma già in sede di apertura della procedura familiare la giurisprudenza ha evidenziato due diverse modalità di fornire le indicazioni operative al liquidatore[6].
In un primo approccio, in numerose sentenze la parte dispositiva non diverge dal contenuto adottato in caso di domanda singola, nel senso che la pluralità dei ricorrenti non modifica gli incombenti posti a carico del liquidatore: egli è invitato ad aggiornare l’elenco dei creditori e l’inventario, a inoltrare la comunicazione ai creditori indicando il termine per la presentazione delle domande di ammissione, a predisporre uno stato passivo e il programma di liquidazione, nonché al deposito delle relazioni periodiche e, terminata l’esecuzione, il rendiconto (cfr. Trib. Busto Arsizio 29 settembre 2025).
In un diverso approccio, altri tribunali indicano i medesimi incombenti all’unico liquidatore precisando che essi vanno assolti per ciascuna singola procedura, sul presupposto, appunto, che “pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell’art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte distinte procedure di liquidazione, relative ai diversi patrimoni dei ricorrenti” (Trib. Modena 31 marzo 2023), per cui per ciascun debitore dovranno essere predisposti distinti stati passivi e programmi di liquidazione[7].
Si osserva che “i vantaggi del ricorso congiunto, consistenti nella nomina di un unico OCC, con conseguente risparmio di costi, nella possibilità di nominare lo stesso liquidatore per tutte le procedure e nella concentrazione della competenza in capo al giudice adito, anche se i familiari sono residenti in circondari diversi, non fa venire meno la “la persistente operatività del principio di separazione tra procedure” (Trib. Pescara 23 luglio 2024).
b) In riferimento alle procedure negoziali del consumatore e del concordato minore, invece, il principio della distinzione delle masse attive e passive porta a ritenere che:
i) ciascun debitore ricorrente risponde con il proprio patrimonio dei debiti comuni e di quelli personali, ma non dei debiti altrui dei quali siano esclusivi titolari altri familiari;
ii) non è dunque possibile impostare il piano unitario prevedendo la devoluzione di risorse di un debitore a sostegno del piano del proprio familiare, fatta salva la fattispecie, piuttosto infrequente, del pagamento integrale dei propri debiti e dell’esistenza di un residuo attivo da destinare al piano del proprio familiare[8];
iii) la procedura familiare, dunque, non fa sorgere un’obbligazione solidale tra i membri ricorrenti;
iv) in caso di incapienza dei beni su cui insiste il privilegio del creditore, attestata dall’OCC, il piano dovrà prevedere il soddisfo di questi nei limiti del valore del bene, dovendosi tener conto esclusivamente del patrimonio del singolo componente della famiglia nei cui confronti può essere fatta valere la prelazione.
Ciò conduce a ritenere, a titolo esemplificativo, che il creditore assistito da privilegio mobiliare generale (per es., l’Agenzia delle Entrate per crediti erariali) nei confronti di uno solo dei familiari ricorrenti, benché goda altresì di privilegio sussidiario immobiliare, non può essere preferito ai creditori dell’altro familiare sul ricavato della liquidazione dell’immobile di proprietà esclusiva di quest’ultimo.
v) Il piano unitario di concordato potrà essere omologato ove le maggioranze siano raggiunte in relazione a tutte le masse passive e per ciascuno dei familiari ricorrenti[9].
Peraltro, non è ritenuto invalido l’eventuale voto unico espresso in riferimento al piano unitario, indirizzato sulla proposta o sulle proposte in cui quel soggetto è annoverato quale creditore, così come, in ipotesi di mancata espressione del voto, i creditori comuni devono ritenersi consenzienti in riferimento a tutte le proposte che li vede creditori, mentre i creditori di un solo familiare, ove silenti, si intendono favorevoli in riferimento alla sola proposta del loro diretto debitore.
vi) Analogamente, in caso di contestazione del creditore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70, comma 7) o nel concordato minore (art. 80, comma 3), il giudizio di convenienza sarà formulato sull’alternativa liquidatoria riguardante il debitore, o i debitori, del creditore opponente.
4.2. Pluralità di domande distinte (quarto comma)
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento.
La competenza appartiene al giudice adito per primo.
Il quarto comma regola la fattispecie della pluralità di domande distinte presentate da membri della stessa famiglia, impartendo regole di coordinamento tra le procedure e incidendo sulla disciplina generale della competenza, di cui agli artt. 29 ss. CCII.
Si stabilisce che i familiari possono depositare la domanda innanzi al Tribunale adito per primo dal proprio congiunto, anche se la residenza ricade in altro foro.
In presenza di istanze plurime e distinte presentate innanzi allo stesso foro, il Tribunale coordinerà le procedure disponendone la riunione, mentre ove le domande distinte risultino presentate presso fori diversi, in relazione al luogo di residenza di ciascun familiare, si stabilisce l’attrazione al foro preventivamente adìto delle procedure successivamente avviate.
Peraltro, la formulazione della norma porta con sé alcuni disallineamenti:
a) il primo attiene al riferimento ai ‘membri della stessa famiglia’, che dovrebbero ragionevolmente essere quelli di cui alla nozione del comma 2, che però pone la definizione solo “ai fini del comma 1”, non ricomprendendo la fattispecie di cui al comma 4; tuttavia, non c’è motivo per ritenere che la disciplina delle domande plurime attenga ad un diverso perimetro soggettivo;
b) il secondo rilievo riguarda il diverso oggetto delle istanze distinte, in quanto ciò che nel primo comma è indicato come “un’unica domanda di accesso ad una delle procedure”, nel quarto comma la formula utilizzata dal legislatore regola il coordinamento in presenza di “più richieste di risoluzione della crisi”, quasi che la regola operi anche in presenza di procedure eterogenee presentate autonomamente dai membri della stessa famiglia[10];
c) il terzo aspetto, più sostanziale, riguarda la circostanza per cui le regole di coordinamento e competenza sembrano richiedere solo l’appartenenza dei ricorrenti alla stessa famiglia, senza che sia necessario il requisito ulteriore della convivenza ovvero dell’origine comune del sovraindebitamento, diversamente da quanto previsto al comma 1 per la domanda unitaria: tale lettura letterale genera, tuttavia, qualche perplessità, ove si consideri che la vis attractiva del Tribunale adito per primo - conseguente al mero vincolo familiare, tra soggetti neppure conviventi, né legati dall’origine comune del debito - potrebbe apparire eccessivamente gravosa per il familiare che agisca per secondo e che intenda regolare autonomamente la propria situazione di sovraindebitamento presso il foro della propria residenza, in assenza, va ribadito, del requisito della convivenza e/o dell’origine comune del debito con il familiare che ha agito per primo;
d) la considerazione appena svolta porta a chiedersi: ma il foro adito per primo radica una competenza territoriale inderogabile o la norma assegna solo una facoltà del familiare ?
In altri termini, prevedere che la competenza appartiene al giudice adito per primo significa offrire un’opportunità al familiare che agisce per secondo, per cui in suo favore, oltre al foro competente, si aggiunge anche la competenza del foro presso cui si è per primo rivolto il proprio familiare, oppure la preventiva iniziativa di questi fa venire meno l’originaria competenza territoriale?
Se così è - come purtroppo sembra, nel senso della previsione di una competenza territoriale inderogabile - se a proporre per primo la domanda fosse uno solo dei membri del nucleo familiare, il giudice adito sarebbe competente in via esclusiva in ordine alle istanze successive degli altri congiunti[11].
e) infine, è evidente l’interferenza del quarto comma con la disciplina generale sulla competenza, regolata dagli artt. 29 ss. CCII, da cui si discosta per un aspetto non di poco conto.
Richiamando l’art. 30 CCII, qui ripreso per comodità
si vede che nella norma generale il riferimento temporale non è alla presentazione del ricorso, come indicato per le procedure familiari; l’art. 30 CCII menziona infatti l’apertura della procedura, non il momento del deposito della domanda, per cui nell’art. 66 CCII la competenza si radica in favore del giudice adito per primo, e non del Tribunale che si è pronunciato per primo; è dunque sufficiente il deposito del ricorso per far scattare la regola sulla competenza.
Inoltre, con riferimento all’art. 31 CCII circa la salvezza degli effetti, a tacere del fatto che l’attività dell’OCC, indispensabile ai fini dell’apertura della procedura, viene avviata prima del deposito della domanda di accesso, c’è da chiedersi se possa essere conservato e valorizzato il lavoro del gestore della crisi che abbia assistito il debitore fino alla consegna della relazione ed al deposito della domanda di accesso: è ragionevole ritenere che la traslatio del procedimento, infatti, impatti sulla validità della relazione del gestore della crisi, elemento indefettibile per l’accesso del debitore alla procedura.
Detto elaborato non potrà ritenersi valido in ipotesi di trasferimento in favore del primo giudice, potendo l’OCC operare esclusivamente nel distretto ove è costituito; se ciò è vero, il debitore dovrà richiedere la nomina del gestore ad un OCC competente, operante presso il distretto del foro competente, ai fini della nomina di un nuovo gestore e la redazione di un nuovo elaborato, ovviamente utilizzando, ove ritenuto opportuno, la documentazione acquisita dal primo gestore.
f) Infine, cosa succede quandole procedure prescelte dai familiari che agiscono con ricorsi distinti sono di competenza l’una del giudice monocratico e l’altra del giudice collegiale ?
Si ritiene che non sussistano problemi ove il primo procedimento iscritto a ruolo - che esercita vis attractiva sui successivi procedimenti radicati altrove dai propri familiari - riguardi l’istanza di apertura della liquidazione controllata; diversamente, ove la domanda più risalente appartenga alla competenza del giudice monocratico, l’art. 281 novies c.p.c. dettato in tema di connessione imporrà al giudice la trasmissione al collegio ai fini della trattazione unitaria di entrambe le domande presentate.
5. Requisiti soggettivi: qualificazione eterogenea dei familiari
L’art. 66 CCII fornisce scarne indicazioni sulla qualificazione dei familiari ricorrenti.
Esso si limita a disporre che
a) se almeno un membro non è consumatore, non si applica la disciplina ex art. 67 CCII, fatta eccezione per la previsione del quinto comma di detto articolo, che consente la prosecuzione del mutuo ipotecario, avente ad oggetto l’abitazione principale, senza che sia necessaria alcuna attestazione dell’OCC, invece prevista nell’identica fattispecie regolata nel concordato minore;
b) nella liquidazione controllata familiare, se un membro si trova nella condizione di incapienza ex art. 283 CCII, questi è attratto dalla procedura liquidatoria di gruppo, a condizione che essa non sia antieconomica, ovvero che l’OCC attesti che c’è attivo da distribuire ai creditori almeno in riferimento ad un familiare, ex art. 268, comma 3, ultimo periodo (con ciò dovendosi chiarire che il familiare ‘incapiente’ perverrà all’esdebitazione, in presenza dei presupposti di legge, ex art. 282 CCII e non ex art. 283 CCII).
L’art. 66 CCII non aggiunge altro, ma consente di ricostruire il perimetro soggettivo delle procedure familiari, per cui si può dire che:
- se tutti i familiari ricorrenti sono consumatori, essi possono proporre unitariamente una ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII o richiedere l’accesso alla liquidazione controllata di gruppo;
- se almeno un membro non è consumatore, questi potrà essere imprenditore minore o imprenditore agricolo, e l’intero gruppo familiare potrà presentare un concordato minore o accedere alla procedura liquidatoria;
- se almeno un membro non è consumatore, ma imprenditore commerciale sopra-soglia, egli non potrà partecipare al progetto unitario essendo astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale, per cui gli altri membri potranno presentare una domanda unitaria ex art. 66, comma 1, o più domande coordinate ex art. 66, comma 4, in ogni caso in modo separato e autonomo dalla procedura di liquidazione giudiziale che dovesse riguardare il proprio familiare; ove questi dovesse presentare uno strumento negoziale ‘maggiore’, come il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, tale procedura andrà coordinata con le procedure dei familiari, in assenza peraltro di criteri normativi idonei a radicare la competenza innanzi ad un unico giudice per tutte le procedure;
- se un membro è socio illimitatamente responsabile di società sopra-soglia, egli è considerato consumatore per i debiti personali e non sociali, potrà dunque accedere alla procedura familiare per definire esclusivamente i propri debiti consumeristici; peraltro, in riferimento ai debiti sociali, se la società partecipata dovesse accedere ad uno strumento negoziale ‘maggiore’, il socio potrebbe beneficiare in estensione degli effetti esdebitatori di detto strumento, ai sensi dell’art. 59 CCII (accordo di ristrutturazione) o art.118 CCII (concordato preventivo), mentre se la società entrasse in liquidazione giudiziale, questa determinerebbe l’apertura di analoga procedura in capo al socio illimitatamente responsabile, ex art. 256 CCII;
- alcun problema di coordinamento per il familiare che fosse socio di società di capitali con debiti di garanzia, ben potendo proporre con i familiari una domanda unitaria ex art. 66, comma 1, o più domande coordinate ex art. 66, comma 4, accedendo alla liquidazione controllata o a un concordato minore di gruppo; analogamente l’imprenditore agricolo può sempre accedere alle procedure di sovraindebitamento familiare, a prescindere dalle soglie, come pure in presenza di impresa familiare ex art. 230 bis c.c. con familiari garanti, l’intero nucleo potrà proporre una domanda unitaria ex art. 66 CCII.
Si segnala, infine, che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la riunione ex art. 7-bis l. 3/2012 delle procedure proposte da membri della stessa famiglia e dalla società di persone tra loro costituita, avendo maturato una debitoria comune operando per il tramite di detto ente sociale (cfr. Trib. Ravenna 3 marzo 2021).
6. Qualificazioni eterogenee dei familiari e procedura unitaria: quale disciplina applicabile?
Ci chiediamo se in presenza di una domanda unitaria ex art. 66, comma 1, o più domande coordinate ex art. 66, comma 4, avente ad oggetto la medesima procedura di sovraindebitamento, la relativa disciplina trovi applicazione in riferimento a ciascun familiare ricorrente, anche in presenza di qualifiche eterogenee degli stessi.
La risposta dovrebbe essere positiva, per cui - a titolo esemplificativo - se i membri della stessa famiglia si dividono tra consumatori e non consumatori, la procedura unitaria di concordato minore regola anche la posizione del familiare-consumatore, per es. riconoscendo il diritto di voto ai suoi creditori.
Del resto, la regola per cui l’incapiente è attratto alla disciplina della liquidazione controllata familiare, dovrebbe tradurre la volontà del legislatore di ‘rivestire’ il progetto unitario, o la soluzione liquidatoria, con il medesimo strumento concorsuale, per cui la conseguente disciplina sostanziale dovrebbe regolare la procedura unitaria in riferimento a ciascun membro ricorrente.
La questione non è di poco conto; si pensi al fatto che il piano del consumatore può avere un ‘contenuto libero’, mentre il piano del concordato minore soggiace ad un maggior rigore di impostazione; ove vi sia un non consumatore tra i familiari ricorrenti, non è ipotizzabile che, in ragione della qualifica di consumatore di un altro membro ricorrente, questi possa impostare un piano dal contenuto regolato dall’art.67 CCII.
Nel caso tipico del concordato minore familiare di tipo liquidatorio, ad es., l’apporto di risorse esterne in misura apprezzabile ex art. 74, comma 2, CCII integra un requisito di ammissibilità: ci si chiede se esso vada riscontrato in riferimento a tutte le masse attive, e dunque anche del familiare-consumatore, o può riguardare solo il soggetto che non riveste la qualifica di consumatore.
Le opzioni interpretative sono aperte, da quella che ritiene più conforme al sistema la soluzione che prevede l’applicazione a tutti i familiari ricorrenti delle regole sostanziali dello strumento prescelto, a quella che consente al giudice, chiamato a valutare l’incremento delle risorse esterne “in misura apprezzabile”, una delibazione complessiva del progetto unitario proposto, anche in termini di convenienza per tutti i creditori, soluzione quest’ultima forse preferibile e di maggior buon senso.
Analogamente, in ordine ai profili soggettivi di ammissibilità, tenuto conto delle diverse condizioni ostative previste dagli art. 69 CCII (procedura del consumatore) e dall’art. 77 CCII (concordato minore), viene da chiedersi se il concordato minore di gruppo consenta al familiare-consumatore di ‘beneficiare’ della regola, più favorevole al debitore, che nega l’ammissibilità del concordato solo in presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77), non anche ove l’indebitamento sia stato determinato da colpa grave (art. 69).
Circa detto profilo soggettivo - di particolare rilievo in quanto attiene alla ‘meritevolezza’ del debitore ai fini dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento – mi pare più convincente l’opinione che muove dalla necessità di esaminare le posizioni personali dei partecipanti al piano familiare, ascrivendo al singolo membro le conseguenze negative della propria condotta, ma sulla base delle norme sostanziali dell’unico strumento prescelto[12].
6.1. Profili di inammissibilità riguardanti il singolo familiare ricorrente
Connessa a tale problematica viene in evidenza la questione della possibilità o meno, per il giudice, di valorizzare eventuali profili di inammissibilità che dovessero colpire un solo familiare ricorrente, anche nell’ipotesi in cui non vi fossero problemi di qualificazione eterogenea dei familiari ricorrenti.
Per esempio, ove tutti i familiari fossero consumatori e accedessero alla domanda unitaria ex art. 66, comma 1, CCII, per la presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, nondimeno il giudice potrebbe riscontrare un vizio di inammissibilità solo in capo ad un ricorrente.
Ciò detto, dunque, si apre la questione degli effetti sul piano familiare dell’inammissibilità accertata in capo al singolo membro.
In dottrina e giurisprudenza constano due orientamenti.
C’è chi ritiene che l’inammissibilità che colpisce un solo familiare renda inammissibile la domanda unitaria ex art. 66, comma 1, CCII, proprio in ragione del carattere unitario ed inscindibile del ricorso, per cui il giudice, rilevando la condizione ostativa a carico di un solo membro ricorrente, non potrebbe semplicemente escluderlo[13].
Un diverso orientamento osserva invece che in ipotesi di presentazione di un’unica domanda di procedura familiare nulla osta alla separazione della posizione dei debitori nel caso in cui per uno di loro non sussistano le condizioni per l’accesso alla procedura richiesta[14].
6.2. Revoca dell’omologazione per fatto del singolo familiare ricorrente
Analogamente, riguardo la revoca della sentenza di omologazione nelle procedure del consumatore o nel concordato minore, disciplinata rispettivamente dagli artt. 72 e 82 CCII - con fattispecie tra loro eterogenee come l’inadempimento o il compimento di atti di frode - ci si chiede se possa spezzarsi il carattere unitario della sentenza, nel caso in cui, per es., il piano non sia adempiuto da un solo membro, in presenza di adempimento integrale del piano da parte di un altro familiare, anche in virtù del fatto che le ipotesi di revoca sono tassative e la sentenza di omologa spiega gli effetti del giudicato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Taluni hanno richiamato la disciplina del codice civile in tema di patologie dei contratti plurilaterali, ovvero di annullabilità, risoluzione e impossibilità della prestazione riguardante un solo contraente (artt. 1446, 1459 e 1466 c.c.), per cui il vizio che attiene ad una sola parte non pregiudica l’intero contratto - così ammettendo l’ammissibilità di una risoluzione o annullamento parziale dello stesso - “a meno che la prestazione mancante sia considerata essenziale secondo le circostanze”.
Di segno opposto rispetto alle citate norme del codice civile, tuttavia, vige il principio sancito dall’art. 286, comma 8, CCII, dettato in riferimento alle procedure di concordato preventivo di gruppo, per cui “il concordato di gruppo omologato non può essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti per la revoca, risoluzione o l’annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese”.
La codificazione da parte del legislatore di tale regola valevole per il concordato di gruppo - si è sostenuto - dovrebbe valere non soltanto per il gruppo societario ma anche per il gruppo familiare.
Tuttavia, alla stregua della richiamata disciplina del codice civile, e facendo leva sul principio della distinzione delle masse attive e passive, si ritiene preferibile, perché ispirata a buon senso, la posizione di coloro che non intendono pregiudicare il familiare che ha ben operato e adempiuto quanto promesso ai propri creditori, rispetto al congiunto che si è reso inadempiente o, addirittura, ha compiuto atti in frode, per cui il Giudice dovrebbe poter limitare gli effetti della revoca solo a carico del soggetto inadempiente.
[1] L’Autore è avvocato in Rimini e Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all’Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Il presente contributo costituisce una rielaborazione della relazione tenuta dall’A. il 23 ottobre 2025 al Convegno “MI.MA. 2025” dal titolo “Il patrimonio del debitore al servizio dei creditori” organizzato a Milano Marittima da ODCEC e Fondazione Commercialisti di Ravenna unitamente a UNIBO Ravenna e OCC Romagna, sul tema “Le procedure familiari”.
Le sentenze citate sono in parte pubblicate su questa Rivista e in parte nella disponibilità dell’Autore, a disposizione del lettore (mancini@studiomanciniassociati.it).
[2] Cfr. Trib. Udine 18 maggio 2021 per cui “va respinta l'istanza di trattazione congiunta ex art.7 bis legge 3/2012 (procedure familiari) con quella analoga presentata dal famigliare del ricorrente, considerato che l'istituto della procedura familiare si riferisce letteralmente alla sole procedure di composizioni della crisi, non a quella di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012 che, invece, è alternativa alle prime” (conforme, Trib. Rimini 11 febbraio 2022).
Contra, favorevole al ricorso congiunto ex art. 7-bis l. 3/2012 per l’apertura della liquidazione del patrimonio, cfr. Trib. Mantova 31 maggio 2021; Trib. Verona 12 maggio 2021; Trib. Busto Arsizio 18 marzo 2021).
[3] Malgrado il mancato rinvio normativo, la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto comunque ammissibile la domanda congiunta ex art. 283 CCII “pur in assenza di esplicito richiamo, per evidenti ragioni di economia processuale e contenimento delle relative spese” (così, Trib. Rimini 24 luglio 2025; conforme, Trib. Ancona 2 ottobre 2023; Trib. Pisa 3 luglio 2024; Trib. Perugia 3 maggio 2025, Trib. Lecco 16 settembre 2025).
Trib. Perugia 3 maggio 2025 ha motivato osservando che “il CCII ha espressamente previsto la possibilità di plurime domande nella parte in cui ha disposto che la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno più debitori si trovano nella condizioni di cui all’art. 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’art. 268, comma 3, quarto periodo, apparendo così aprire alla possibilità di domande per plurime incapienze ex art. 283 CCI”.
[4] Fattispecie in cui il Giudice bolognese “non ricorrendo i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata”, ha dichiarato “l’incompetenza di uno dei ricorrenti risultante residente in altra circoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 CCII”.
[5] Di recente, Trib. Padova 11 dicembre 2024 ha aperto la liquidazione controllata a seguito di domanda congiunta di familiari aventi residenza in foro diversi.
[6] Per una panoramica delle diverse indicazioni fornite in sede di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, come emerse in giurisprudenza dopo la l. 137/2020, sia consentito il rinvio al mio contributo “Procedure familiari ex art. 7-bis. l. 3/2012 e liquidazione del patrimonio (Brevi note su ammissibilità e competenza)”, in questa Rivista, aprile 2022.
[7] Osserva il Giudice modenese nella pronuncia richiamata, che dalla distinzione delle masse attive e passive “consegue che l’attivo ricavato dalla liquidazione delle masse patrimoniali dei singoli ricorrenti dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori personali e di quelli comuni agli altri ricorrenti; pertanto il ricavato dalla liquidazione del patrimonio di uno dei ricorrenti istanti non potrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori esclusivamente personali di un altro ricorrente che prende parte ad una procedura di tipo familiare.
Inoltre alle incombenze di cui agli artt. 272 ss., ossia redazione dell’elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., il liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l’obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse”. (Trib. Modena 31 marzo 2023).
[8] Trib. Roma 14 febbraio 2023 ha ritenuto ammissibile il concordato minore familiare in cui ”le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente sono state tenute distinte, per cui l’attivo messo a disposizione da ognuno di loro sarà destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e dell’unico creditore all’altro ricorrente”.
[9] Tribunale di Nola 12 giugno 2024 ha respinto l’omologa di un concordato minore familiare in cui il voto favorevole era stato raggiunto solo in riferimento ad uno dei coniugi.
[10] Si dica però che non constano pronunce giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’art. 66, quarto comma, CCII, in presenza di procedure eterogenee.
Trib. Bari 8 ottobre 2023 ha ritenuto inammissibile la domanda unitaria ex art. 66, primo comma, di un nucleo familiare di 4 persone in cui due ricorrenti chiedevano l’esdebitazione ex art. 283 CCII mentre gli altri due familiari instavano per l’accesso alla ristrutturazione ex art. 67 CCII, disponendo la separazione delle domande congiunte ex art. 283 CCII, da istruire con separato fascicolo, e l’apertura della procedura unitaria del consumatore.
[11] Con buon senso, contro questa interpretazione che potrebbe rendere eccessivamente gravosa l’iniziativa del familiare che agisce per secondo, si è espresso Trib. Ivrea 3 marzo 2022 che ha dichiarato ammissibile la procedura avviata dal familiare innanzi al foro di residenza, "pur in presenza di procedure di sovraindebitamento autonomamente avviate dai suoi familiari avanti ad altro foro, malgrado la situazione debitoria di tutti i familiari sia unitaria”, di fatto stabilendo la facoltatività della scelta del foro.
Il Tribunale di Ivrea muove dalla considerazione che la norma deve agevolare l’accesso alle procedure, non renderlo più difficile. Si osserva dunque che la previsione del quarto comma non è idonea “a determinare una modificazione della competenza territoriale in caso di proposizione di plurime, separate procedure, atteso che: 1) la ratio della disposizione da ultimo menzionata è ravvisabile nella necessità di consentire al debitore sovraindebitato di poter accedere alla tutela giudiziaria senza dover affrontare ingenti costi per instaurare la procedura in una località diversa da quella in cui risiede (tutela che prevale sulle esigenze di coordinamento in caso di instaurazione di distinte procedure da parte di membri della stessa famiglia – non conviventi – il cui indebitamento presenta un’origine comune); 2) l’art. 7 bis cit. non impone ai membri della stessa famiglia alcun obbligo di presentazione di un unico piano di composizione della crisi, limitandosi a sancire l’ammissibilità dell’eventuale procedura così instaurata (in tal caso sancendo l’ammissibilità della procedura azionata presso il Tribunale nel cui circondario è ubicato il comune di residenza di uno solo degli istanti)”.
[12] Ove fosse questa l’interpretazione corretta, a carico del familiare-consumatore che partecipa al concordato minore di gruppo non dovrebbe rilevare lo stato soggettivo della colpa grave ma solo la frode.
[13] È forse questo l’orientamento espresso da R.BROGI, “Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi”, Wolters Kluwer, 2024, pag. 508, anche sul presupposto che rilevare l’inammissibilità a carico di uno dei ricorrenti, a fronte di una domanda unitaria, determinerebbe una non consentita modifica giudiziale del piano di ristrutturazione dei debiti.
[14] Cfr. Trib. Sondrio 21 novembre 2024, resa in fattispecie di domanda unitaria di apertura della procedura di liquidazione controllata in cui uno dei debitori familiari risultava essere un imprenditore sopra-soglia, ha respinto la domanda a carico del ricorrente privo dei presupposti di accesso alle procedure di sovraindebitamento e aperto la procedura a carico dell’altro familiare.
Nello stesso senso, in dottrina si è osservato: “Non si vede per quale ragione il giudice non possa, nel piano familiare, eterodirigere il procedimento nel senso di assegnare ai ricorrenti un termine, ex art. 47, comma quarto, CCII, per modificare il piano tenendo conto della condizione di inammissibilità in cui versa uno dei ricorrenti. Il tutto, ovviamente, è subordinato alla condizione che quella posizione non sia decisiva ai fini della qualificazione della domanda quale domanda “di gruppo”, la qualcosa, a titolo esemplificativo, potrebbe accadere nel caso di piano presentato da due soli familiari o di piano il cui attivo provenga dal familiare la cui posizione sia destinata al rigetto” (cosìR.D’ALONZO, ”I profili processuali della ristrutturazione dei debiti del consumatore”, in Dirittodellacrisi, 20.5.2024).
Scarica Articolo PDF